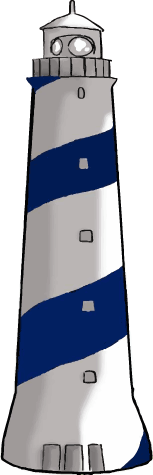Lo sapevate? Un tempo una vera lupa e un’aquila vive, erano mostrate in gabbia come simboli di Roma.

Dal 1872 venivano mostrati i due animali in carne ed ossa nelle rispettive gabbie. La pietosa pratica continuò fino agli anni Settanta
La lupa che allattò Romolo e Remo e l’aquila che rappresentava l’Icona di Giove, padre di tutti gli dei, sono due simboli di Roma archetipici.
Non tutti sanno che gli esemplari vivi di questi animali, venivano mostrati in due gabbie posizionate sulla rupe tarpea, la parete rocciosa del Campidoglio, dalla quale venivano lanciati i traditori condannati a morte. Il suo nome deriva da Tarpeia, una giovane che s’innamorò del comandante dei Sabini e per questo tradì la propria città consegnandola all’esercito nemico.
Su questa controversa rupe, dal 1872 venivano mostrati i due animali in carne ed ossa nelle rispettive gabbie. La decisione fu presa dal Consiglio comunale di Roma, presieduto dal Sindaco Pietro Venturi. Ovviamente all’epoca non vi era la stessa consapevolezza di adesso relativamente ai diritti degli animali e furono stabiliti anche i costi di 23,50 lire al mese.
Anselmo C, un simpatico uomo di 85 anni, ci racconta di ricordare ancora sia la lupa che l’aquila nelle gabbie. “La povera lupa camminava avanti e indietro, nervosa” ha affermato.
Si tratta di un comportamento tipico degli animali in cattività, che i cittadini avevano presente molto bene al punto che nacque il modo di dire “me pari la lupa del Campidojo a Roma” per indicare una persona irrequieta, che si muove spesso e che non trova pace.

La condizione pietosa di questi animali fu oggetto di discussione, soprattutto dopo la morte di una di queste lupe di appena tre anni. Addirittura un inglese scrisse al Times chiedendo di non far sostituire l’esemplare, come raccontato da Specchio romano.it e il giornalista Mauro Monti, ma senza successo e anche l’ Ente Protezione Animali manifestò sdegno.
Negli anni Quaranta non fu più ingabbiata nessuna aquila, ma decisero di non mostrare più nessuna lupa fino agli anni Settanta.
Anche Trilussa, ispirato dalla lupa e dall’aquila vive, scrisse due poesie intitolate appunto “Lupa romana” e “Aquila romana” facendo un parallelismo tra la prigionia di questi animali e l’avvento del regime fascista:
“Er giorno che la Lupa allattò Romolo
nun pensò né a l’onori né a la gloria:
sapeva già che, uscita da la Favola,
l’avrebbero ingabbiata ne la Storia”.
“L’antra matina l’Aquila romana,
che ce ricorda, chiusa ne la gabbia,
le vittorie d’un’epoca lontana,
disse a la Lupa: — Scusa,
ma a te nun te fa rabbia
de sta’ sempre rinchiusa?
Io, francamente, nu’ ne posso più!
Quanno volavo io! Vedevo er monno!
M’avvicinavo ar sole! Invece, adesso,
così incastrata come m’hanno messo,
che voi che veda? l’ossa de tu’ nonno?
Quanno provo a volà trovo un intoppo,
più su d’un metro nun arivo mai… —
La Lupa disse: — È un volo basso assai,
ma pe’ l’idee moderne è puro troppo!
È mejo che t’accucci e stai tranquilla…”
nun c’è che l’animale forastiere
che vié trattato comme un cavajere
e se gode la pacchia d’una villa!
L’ultimo Pappagallo de la Mecca,
appena arriva qua, se mette in mostra,
arza le penne e dice: Roma nostra …
E quer che trova becca.
Viva dunque la Scimmia der Brasile!
Viva la Sorca isterica
che arriva da l’America!
Nojantri? Semo bestie da cortile.
Pur’io, va’ là, ciò fatto un ber guadagno
a fa’ da balia a Romolo! Accicoria!
Se avessi da rifà la stessa storia
invece d’allattallo me lo magno!”.
Foto: Archivio Istituto Luce Cinecittà

© RIPRODUZIONE RISERVATA