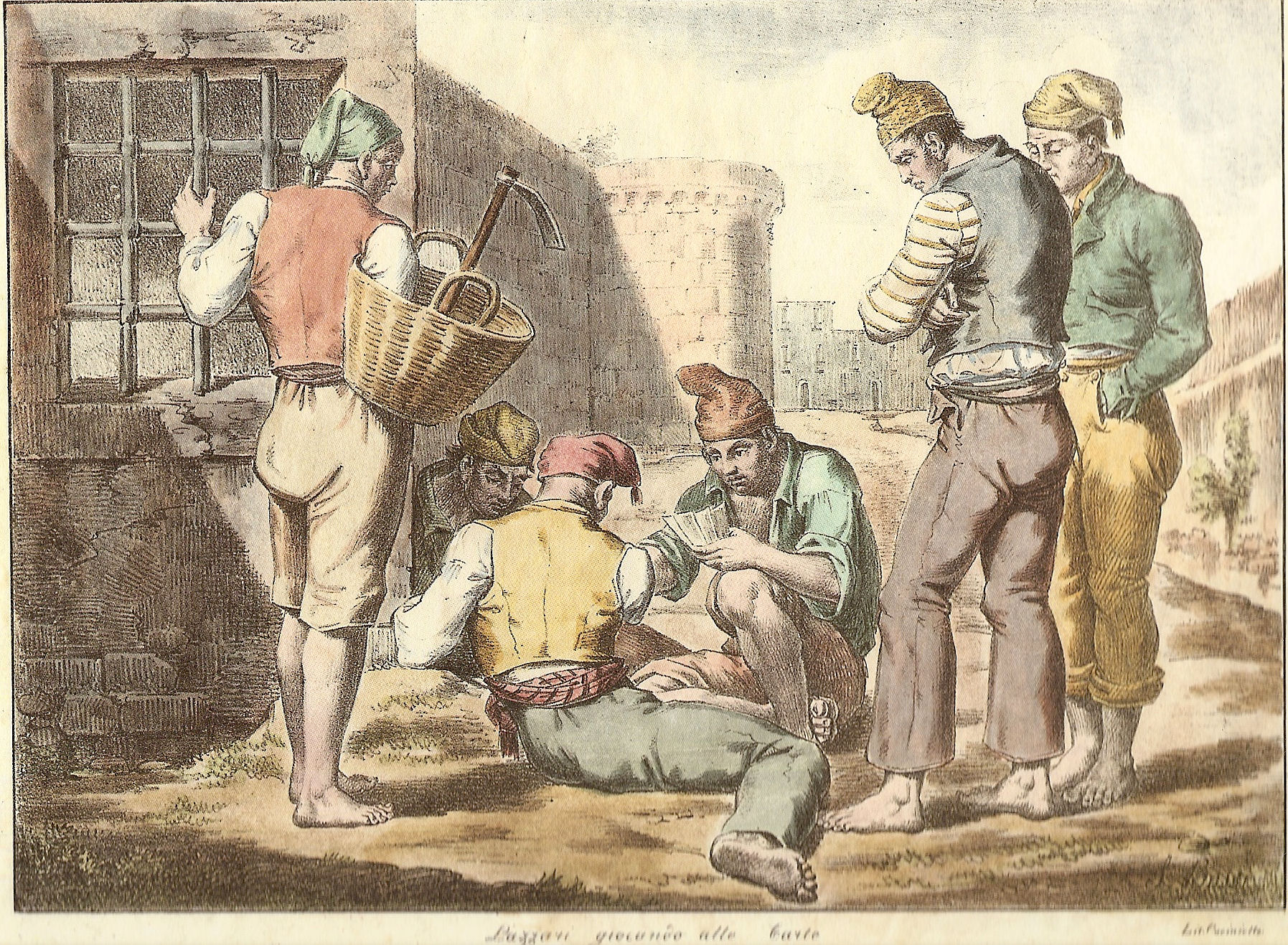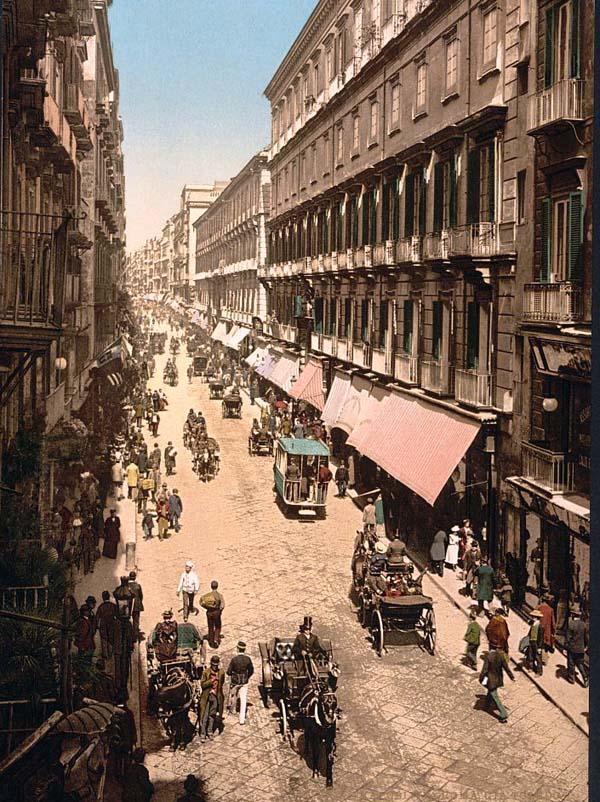Lo sapevate? Che cosa ci fa un’asta di ferro infilata in un pilastro del Duomo di Napoli da oltre 600 anni?

Sapevate che nel Duomo di Napoli, un’asta di ferro è stata infilata in un pilastro per oltre 600 anni? Una curiosa scoperta che sfugge alla vista di molti visitatori. Ma a cosa serve questo pezzo di metallo?
Lo sapevate? Che cosa ci fa un’asta di ferro infilata in un pilastro del Duomo di Napoli da oltre 600 anni?

Sapevate che nel Duomo di Napoli, un’asta di ferro è stata infilata in un pilastro per oltre 600 anni? Una curiosa scoperta che sfugge alla vista di molti visitatori. Ma a cosa serve questo pezzo di metallo?

Si tratta di un’antica unità di misura napoletana, un’asta di ferro che rappresenta il passo napoletano. Questo particolare pezzo, lungo 194 cm, è stato murato verticalmente nell’ultimo pilastro della navata sinistra, proprio prima del transetto.

All’interno di una colonna del pilastro di sinistra dell’arco trionfale del Duomo, si trova questa sbarra di ferro, il prototipo del palmo napoletano. Essa rappresenta fedelmente questa misura di lunghezza in uso nel Regno di Napoli. L’asta di ferro è stata utilizzata come un espediente per evitare confusione e truffe, poiché il valore del palmo poteva variare da città a città e da provincia a provincia. Così, fissando la lunghezza a circa 26 centimetri, si è garantita uniformità e coerenza nella misurazione.
Prima dell’adozione del sistema metrico decimale, le antiche civiltà utilizzavano unità di misura particolari, come il palmo. Questa misura corrispondeva approssimativamente alla distanza tra la punta del pollice e quella del mignolo di una mano aperta di un adulto. Tuttavia, il valore del palmo variava da regione a regione in Italia. A Napoli, ad esempio, dal 1480 al 1840 il palmo era pari a 0,2633333670 metri, ma dopo l’introduzione della legge del 6 aprile 1840, il valore aumentò a 0,26455026455 metri. Una curiosità che evidenzia come le misure siano sempre state un’affascinante sfida per gli esseri umani

Inizialmente sembra un semplice pezzo di ferro arrugginito, un’anonima barretta di metallo che spunta dai dipinti e sembra quasi una deformazione della struttura. Durante i lavori di restauro negli anni ’70 del XX secolo, è stato scambiato erroneamente per un pezzo di rottame di ferro. Fortunatamente, però, un canonico si è accorto che era qualcosa di più e ha fermato gli operai appena in tempo prima che venisse rimosso.
Il Passus Ferreus ha un significato importante, rappresentava l’unità di misura utilizzata in tutti i contratti di compravendita di terreni e, in generale, in ogni accordo commerciale che richiedeva una misurazione accurata. Questo listello di ferro era considerato il campione di misura lineare bizantina, menzionato nei documenti come “Passus Ferreus sanctam Ecclesiam Neapolitanam” per garantire l’integrità e prevenire frodi. Si ritiene che questo antico listello risalga all’epoca giustinianea, quando Napoli divenne un ducato bizantino autonomo.
È importante sottolineare che questo listello è l’unico superstite di molti altri listelli di misura presenti nelle principali chiese delle città bizantine. Inizialmente si trovava nell’abside della Basilica Stefania, ma è stato successivamente spostato nella sua posizione attuale dopo i lavori di costruzione del Duomo angioino.

La sua collocazione sorprende. Questo listello canonico di misura lineare è stato utilizzato fino all’adozione definitiva del sistema decimale francese, ampiamente accettato per la sua praticità, ma successivamente abolito con l’introduzione del sistema nazionale unificato di misure nel 1960.
Il listello rappresentava il campione dell’unità di misura lineare bizantina e, nel corso della nostra storia, è stato richiesto che ogni contratto commerciale lo citasse come garanzia contro frodi. È incastrato nella colonna d’angolo del pilastro principale che sostiene l’arco trionfale del Duomo angioino, alla fine della navata del Salvatore, accanto al vecchio trono del vescovo. Un curioso reperto che ci ricorda come le misure abbiano avuto un ruolo importante nella nostra storia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA