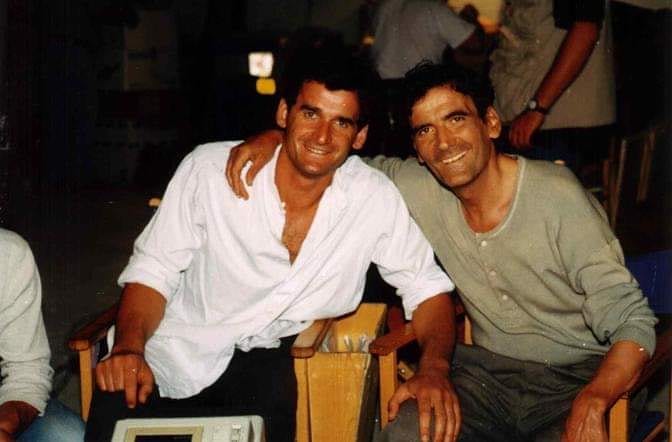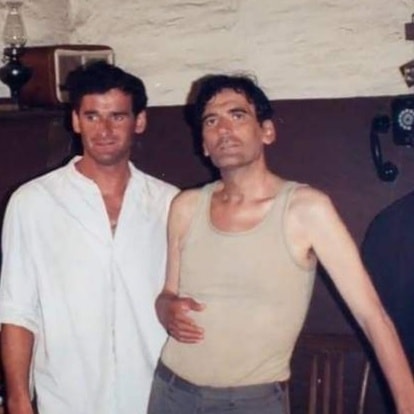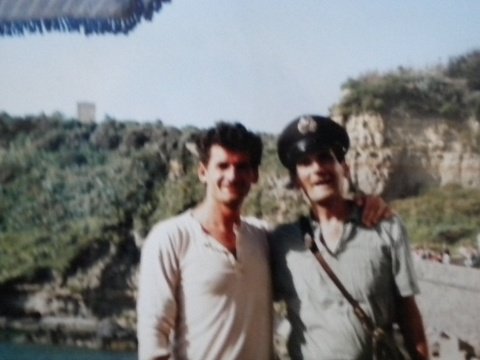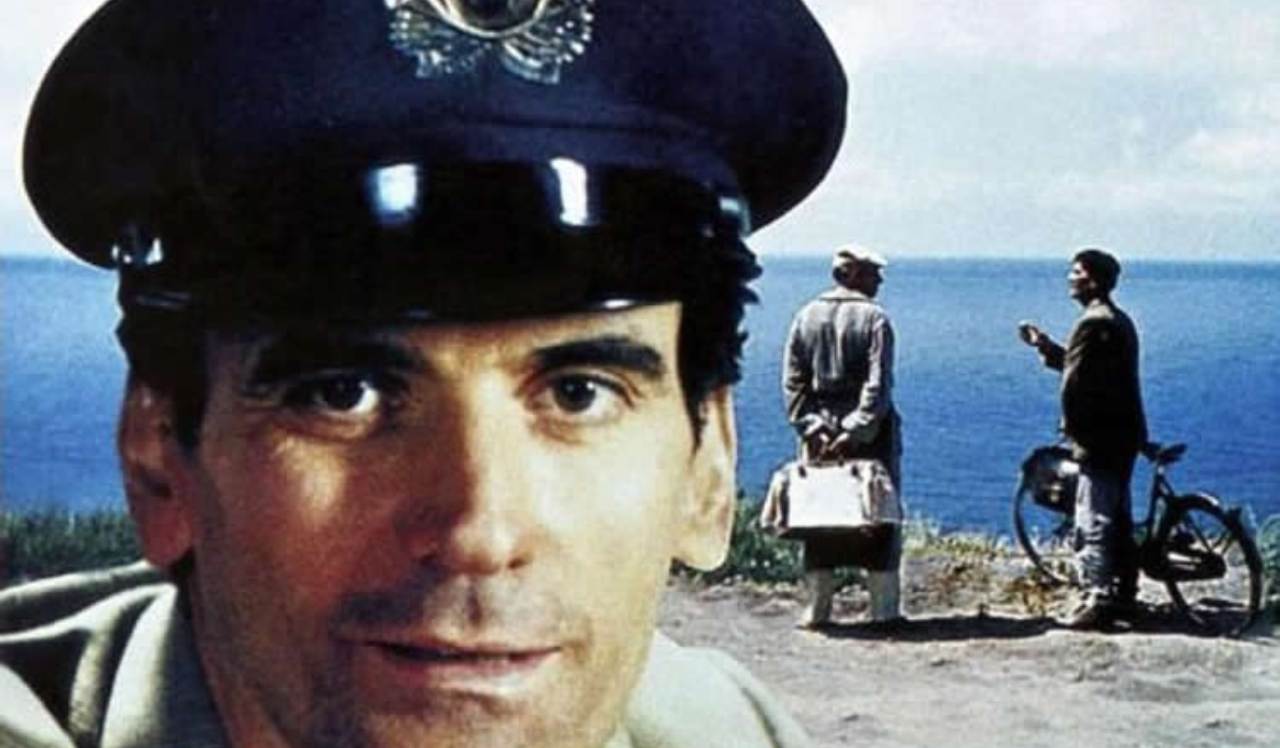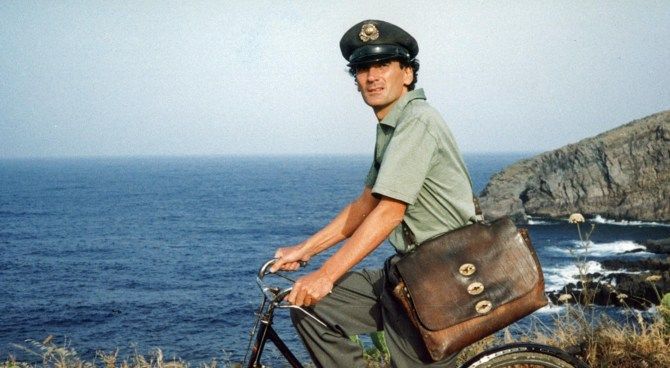Il Vomero, storia di un quartiere un tempo chiamato “Collina dei Broccoli”

La storia della collina vomerese è affascinante per via della radiale trasformazione che ha subito il territorio, da zona a di campagna ad area a forte urbanizzazione. Oggi quartiere dello shopping, vivace e elegante, un tempo era una larga distesa di campi coltivati, il grande orto della città. Scopriamone la lunga storia.
Il Vomero, storia di un quartiere un tempo chiamato “Collina dei Broccoli”.
La storia della collina vomerese è affascinante per via della radiale trasformazione che ha subito il territorio, da zona a di campagna ad area a forte urbanizzazione. Oggi quartiere dello shopping, vivace e elegante, un tempo era una larga distesa di campi coltivati, il grande orto della città. Scopriamone la lunga storia.
 Ne è passato di tempo da quando il Vomero, quartiere collinare della Napoli “bene”, era soprannominato “la collina dei broccoli”, con evidente riferimento alla vocazione agricola del luogo. Al posto dei campi coltivati e della campagna, oggi si ergono palazzi moderni, eleganti edifici di inizio ‘900, palazzi in stile Liberty o più spesso in stile Neoclassico, attraversati da strade trafficate brulicanti di gente e negozi. La quiete dei campi ha lasciato il posto alla vivacità e al caos di un quartiere moderno, che se anche ha perso il fascino rurale che un tempo lo contraddistingueva, rimane in molte delle sue vie una delle zone più belle della città. Ma torniamo alle origini e scopriamo la storia del quartiere: in epoca romana, la collina vomerese era chiamata Paturcium (probabilmente da Patulcius, nome connesso a Giano, il dio a cui la collina era dedicata) e nell’alto Medioevo, per corruzione linguistica, Patruscolo o Patruscio. Il toponimo attuale, attestato alla fine del Cinquecento (quando si riferiva però non all’intera collina, ma ad un antico casale), trae presumibilmente origine dalla sua antica vocazione agricola ed al gioco delvomere, un passatempo contadino che sanciva come vincitore chi, con il vomere dell’aratro, avesse tracciato un solco quanto più possibile dritto.
Ne è passato di tempo da quando il Vomero, quartiere collinare della Napoli “bene”, era soprannominato “la collina dei broccoli”, con evidente riferimento alla vocazione agricola del luogo. Al posto dei campi coltivati e della campagna, oggi si ergono palazzi moderni, eleganti edifici di inizio ‘900, palazzi in stile Liberty o più spesso in stile Neoclassico, attraversati da strade trafficate brulicanti di gente e negozi. La quiete dei campi ha lasciato il posto alla vivacità e al caos di un quartiere moderno, che se anche ha perso il fascino rurale che un tempo lo contraddistingueva, rimane in molte delle sue vie una delle zone più belle della città. Ma torniamo alle origini e scopriamo la storia del quartiere: in epoca romana, la collina vomerese era chiamata Paturcium (probabilmente da Patulcius, nome connesso a Giano, il dio a cui la collina era dedicata) e nell’alto Medioevo, per corruzione linguistica, Patruscolo o Patruscio. Il toponimo attuale, attestato alla fine del Cinquecento (quando si riferiva però non all’intera collina, ma ad un antico casale), trae presumibilmente origine dalla sua antica vocazione agricola ed al gioco delvomere, un passatempo contadino che sanciva come vincitore chi, con il vomere dell’aratro, avesse tracciato un solco quanto più possibile dritto.
Fino alla fine del XIX secolo il Vomero costituiva una periferia pressoché disabitata e lontana dal centro cittadino. Le sue parti più antiche, come il rione Antignano, erano nuclei abitativi rurali, villaggi che sin dai tempi dei Romani sorgevano sulla “Via Puteolis Neapolim per colles” strada che prima dello scavo della galleria di collegamento tra Fuorigrotta e Mergellina costituiva l’unico collegamento via terra tra la zona flegrea e la città. Intorno al II secolo d.C. la strada fu risistemata e chiamata via Antiniana, da cui il nome al rione. Proprio nell’antico villaggio che oggi è il rione di Antignano, la tradizione racconta sia avvenuto per la prima volta il miracolo di San Gennaro, tra il 413 e il 431 d.C. Successivamente, dopo la dominazione Normanna e quella Sveva, nel 1266 con gli Angioini Napoli divenne capitale. Cominciò a sorgere dunque l’esigenza di risalire le pendici della collina vomerese, soprattutto per ragioni strategiche.

La zona cominciò a popolarsi soprattutto a partire dalla costruzione del Chiostro Certosino nel 1325 e quasi contemporaneamente gli Angioini sostituirono l’antico torrione di vedetta (d’epoca normanna) vicino al quale sorse il Chiostro, con il Castello di Belforte, l’originario nucleo del Castel Sant’Elmo. Tutto il resto attorno rimase tuttavia immutato.
Sotto gli Aragonesi e poi sotto gli spagnoli, Napoli andò incontro ad un forte aumento demografico, dovuto alla forte immigrazione dalla penisola iberica e dal resto del regno. La necessità di ampliare il territorio cittadino indusse il viceré Pedro Álvarez de Toledo a dirigere lo sviluppo della città (allora solo pianeggiante) verso le pendici delle colline. Tuttavia, nel 1556 una legge vietò la costruzione di nuovi edifici intorno a Sant’Elmo e, nel 1583, anche sulle pendici del colle. Durante la peste del 1656, la collina fu utilizzata come rifugio da parte della nobiltà e del clero: si era infatti affermata la tendenza nell’aristocrazia residente nel centro storico a costruirsi una seconda casa al Vomero, tendenza che si accentuerà nel corso del Settecento, soprattutto grazie all’apertura della nuova “strada Infrascata” (Via Salvator Rosa). Nel 1817, il Vomero fu promosso al rango di residenza non solo nobiliare, ma anche regale, con l’acquisizione di una villa da parte di Ferdinando I di Borbone: la futura Floridiana. Nel 1809, nella nuova divisione amministrativa della città operata da Gioacchino Murat, tutti i villaggi del Vomero entrarono a far parte della città vera e propria. In due secoli, il quartiere si è sviluppato in maniera progressiva e abbastanza veloce per diventare quello che oggi appare a tutti: una zona elegante e ben curata, che sotto la spinta di una modernità fagocitante ha però perso gran parte del suo antico fascino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA