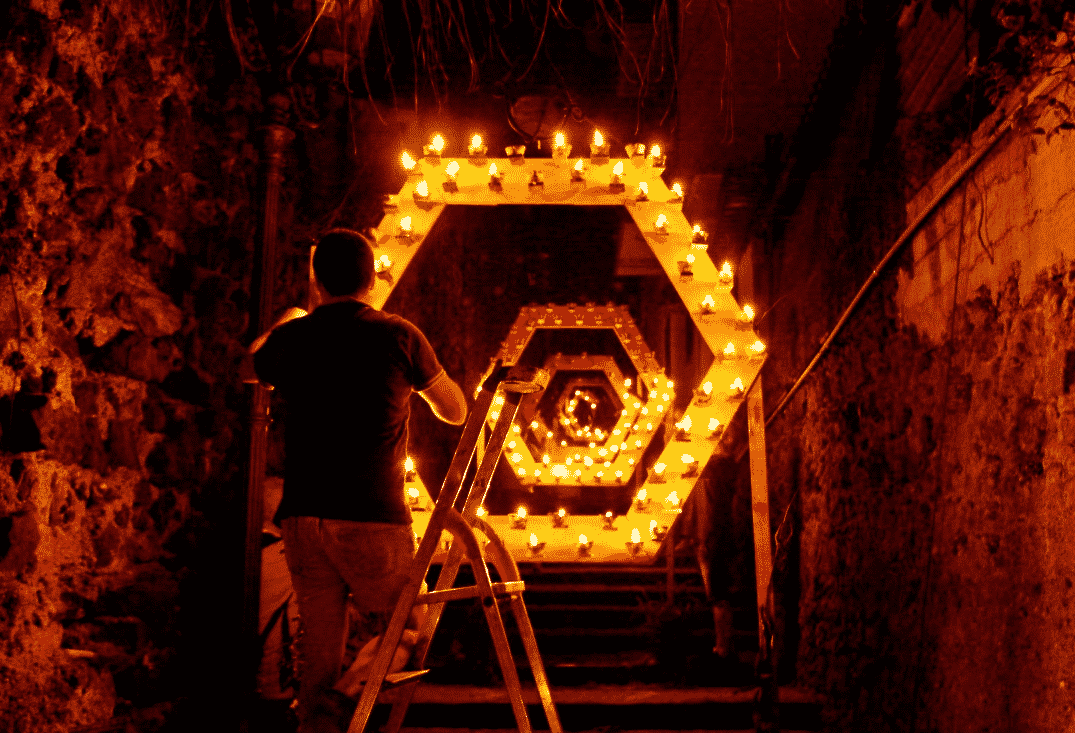Lo sapevate? In una facciata della Galleria Umberto I sono sistemate le statue che rappresentano i quattro continenti

La Galleria Umberto I di Napoli è una struttura gigantesca, lunga circa 147 metri, alta 35 metri e larga circa 15. Ha quattro ingressi: nell'ingresso di via Verdi è possibile ammirare le quattro statue in marmo che rappresentano quattro diverse parti del mondo: l’Europa, l’Asia, l’Africa e l’America, posizionate sull’arco sinistro.
Lo sapevate? Nella facciata della Galleria Umberto I sono sistemate le statue che rappresentano i quattro continenti.

La Galleria Umberto I di Napoli è una struttura gigantesca, lunga circa 147 metri, alta 35 metri e larga circa 15. Ha quattro ingressi: nell’ingresso di via Verdi è possibile ammirare le quattro statue in marmo che rappresentano quattro diverse parti del mondo: l’Europa, l’Asia, l’Africa e l’America, posizionate sull’arco sinistro.

La facciata presenta una vasta decorazione costituita da lesene, stucchi e, soprattutto, grandi statue che, da oltre un secolo, dominano dall’alto la città. Realizzate in marmo dallo scultore carrarese Carlo Nicoli e alte circa tre metri, incarnano in pieno lo spirito dell’epoca.
Da sinistra l’Europa (con ai piedi una lapide con la scritta Corpus Juris Civilis), l’Asia, l’Africa (con casco di banane e la sfinge), l’America (ai piedi tavole geografiche e un globo terrestre con la dicitura Colombo).

Su l’ingresso principale di Via Verdi troviamo raffigurati sulle colonne i Quattro Continenti: la prima statua da sinistra è una donna che regge una lancia in mano e ai piedi una lapide riporta l’iscrizione Corpus Juris Civilis, e rappresenta l’Europa. La seconda figura che stringe a sé una coppa, rappresenta l’Asia. La terza statua abbigliata in stile etnico, ci mostra con una mano un casco di banane e con l’altra si sostiene sopra una sfinge, e questa rappresenta l’Africa. Infine l’ultimo soggetto regge nella mano destra un fascio littorio e ai piedi sono appoggiati un volume di tavole geografiche con un globo terrestre (il nuovo Continente) e rappresenta l’America.
Fissate nella pietra ad affiancare i due archi d’ingresso, anche le personificazioni delle stagioni. Nelle nicchie sovrastanti, a dominare è il pensiero positivista e la fiducia nel progresso con le raffigurazioni della Fisica e della Chimica, del Genio del lavoro e della Scienza. Sulla sommità, ad oltre 30 metri d’altezza, i gruppi con la Ricchezza, affiancata da Commercio e Industria, e l’Abbondanza tra le personificazioni del Telegrafo e dell’energia prodotta dalle nuove macchine a vapore.
La galleria fu progettata dall’architetto Emmanuele Rocco e fu costruita tra il 1887 e 1890. Divenne presto il polo commerciale nonché centro mondano della città; nel 1896 fu scelta come sede della prima sala cinematografica cittadina. Fu dedicata al re Umberto I d’Italia, in ricordo ai suoi aiuti per la popolazione quando scoppiò l’epidemia di colera nel 1884. Oggi la Galleria Umberto I costituisce uno dei più importanti monumenti architettonici della città di Napoli.


Sull’arco di destra troviamo rappresentate sulle colonne altre statue: da sinistra verso destra le Quattro Stagioni, soggetti tradizionali che rappresentano lo svolgersi del tempo a cui sono legate le attività umane, il Lavoro e il Genio della scienza.

Sul fastigio troviamo il Commercio e l’Industria semisdraiati ai lati della Ricchezza, che rappresentano i miti della società borghese odierna.
Nel soffitto del porticato si notano poi una serie di divinità classiche, quali ad esempio Diana, Crono, Venere, Giove, Mercurio e Giunone.
L’ingresso principale è costituito da una facciata ad esedra, che in basso presenta un porticato architravato, retto da colonne di travertino e due archi ciechi.
Seguono finestre a serliana separate da coppie di lesene dal capitello composito mentre ad un secondo piano troviamo finestre a bifora e lesene simili alle precedenti.
L’attico presenta coppie di finestre quadrate e lesene dal capitello tuscanico.
L’interno della galleria è costituito da due strade che si incrociano ortogonalmente, ricoperte da una struttura in ferro e vetro. Sul tamburo della cupola della Galleria Umberto I di Napoli è visibile la Stella di Davide, simbolo della massoneria napoletana, in particolare della loggia massonica Grande Oriente d’Italia, che aveva sede proprio in Galleria.
Oggi la Galleria è un ritrovo commerciale, con alcune delle più importanti boutique napoletane e diversi bar eleganti.

Uno dei simboli della Galleria Umberto I sono gli Sciuscià, gli scugnizzi lustrascarpe. L’espressione dialettale, resa ancora più nota da un vecchio film di Vittorio De Sica, deriva dal vocabolo “shoe-shine”.
I lustrascarpe sino a pochi decenni fa si sistemavano con i propri banchetti negli angoli della Galleria Umberto I, già allora molto frequentata da turisti e ricchi signori. Farsi lustrare le scarpe all’interno della galleria, era una usanza consentita agli uomini chic della città di Napoli. Oggi questo “rito” è scomparso, l’ ultimo sciuscià “veterano”, Antonio Vespa, detto Zì Tonìino, è morto nel 2018.

All’interno della galleria ci sono gli ingressi di quattro stabili, strutturati su cinque piani, di cui i primi due sono utilizzati quasi unicamente per le attività commerciali presenti in Galleria (per lo più negozi di moda e abbigliamento, ristoranti e caffè e un fastfood), mentre gli ultimi tre piani sono destinati ad uffici, qualche abitazione privata e ad alberghi. L’interno degli edifici ha recentemente subito un intervento di restauro che ha riportato all’aspetto originario le molte sculture decorative, gli imponenti busti e le caratteristiche decorazioni liberty. I lavori di restauro tuttavia non sono ancora ultimati ma pian piano procedono per riportare questa splendida struttura al suo antico splendore.

Al secondo piano della facciata principale c’è il museo del corallo e ne occupa la gran parte, dai balconi del museo i rilievi di stucco della facciata del Teatro di San Carlo sono quasi “a portata di mano” e così pure le famose sculture marmoree di Carlo Nicoli che severamente sostengono le ampie finestre dei saloni principali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA