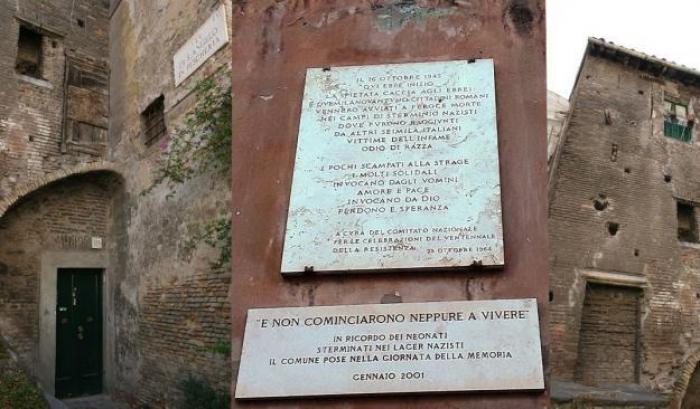Lo sapevate? Perché i sampietrini romani vengono chiamati così?

Lo sapevate? Perché i sampietrini romani vengono chiamati così? Con il termine “sampietrini” si indica il lastricato tipico del centro storico della capitale. Sapete perché si chiamano così? Il nome “sampietrino” o “sanpietrino” (detto anche “selcio”) deriva dal luogo in
Lo sapevate? Perché i sampietrini romani vengono chiamati così?
Con il termine “sampietrini” si indica il lastricato tipico del centro storico della capitale. Sapete perché si chiamano così? Il nome “sampietrino” o “sanpietrino” (detto anche “selcio”) deriva dal luogo in cui questo piccolo blocco di selce, estratto dalle cave poste ai piedi dei Colli Albani e dalle zone vulcaniche del Viterbese, è stato utilizzato per la prima volta, appunto in piazza San Pietro. Il sampietrino rappresenta una tipologia di pavé.

Tecnicamente è un blocchetto di leucitite (una roccia eruttiva tipica delle zone vulcaniche laziali) utilizzato per la realizzazione del lastricato stradale di uso comune nel centro storico di Roma per pavimentare strade o piazze. Ne esistono di diversi tipi e dimensioni: i più grandi misurano 12×12 ×18 cm; quelli più comuni misurano 12×12×6 cm; mentre i più piccoli, 6×6 cm, sono molto rari ma si trovano in alcuni dei luoghi storici di Roma, come in piazza Navona.
Furono ideati nel Cinquecento, per facilitare il passaggio delle carrozze, e dopo oltre 500 anni i sampietrini rappresentano ormai un tratto distintivo di Roma. È stato usato per la prima volta sotto il pontificato di Papa Sisto V e da allora fu largamente utilizzato, per lastricare tutte le strade principali di Roma poiché la sua struttura, meglio degli altri lastricati esistenti, facilitava il passaggio dei carri.

Monsignor Ludovico Sergardi, prefetto ed economo della Fabbrica di San Pietro, dopo aver valutato le pessime condizioni in cui versava piazza San Pietro (poco tempo prima, la carrozza che trasportava il papa si era quasi ribaltata) decise di lastricare la piazza con i caratteristici blocchetti di leucitite.
La denominazione dell’attuale sampietrino nasce nel 1725.

La caratteristica di questo tipo di pavimentazione è di non essere cementata, ma solo posata e poi battuta su un letto di sabbia e/o pozzolana: questo le conferisce elasticità e capacità di coesione e adattamento al fondo stradale. Ha anche il pregio di lasciar respirare il terreno grazie agli spazi tra una piastrella e l’altra; inoltre si può adattare molto facilmente all’irregolarità del terreno ed è molto resistente.
I suoi lati negativi sono che non garantisce un terreno uniforme e, se bagnato, può diventare piuttosto scivoloso, rendendolo inadatto a velocità sostenute. Altro aspetto negativo è il fatto di presentare una superficie poco regolare, quindi poco confortevole e anche rumorosa durante il transito dei mezzi di trasporto.
Non tutti i cittadini li amano, e c’è chi vorrebbe sostituirli con l’asfalto, tanto che nel 2014 il Campidoglio aveva progettato di sostituire la storica pavimentazione della capitale con un manto stradale dalla manutenzione meno costosa e più sicuro per auto, motorini e bus. Un’idea che però non piacque a molti cittadini (e non solo). In passato, qualcuno avrebbe anche proposto di venderli ai turisti: pare infatti che i sampietrini siano molto amati, soprattutto dai cinesi.
Il sampietrino è utilizzato prevalentemente nell’Italia centrale, mentre nell’Italia settentrionale esiste la variante in porfido denominata bolognino perché utilizzato anticamente per la pavimentazione delle strade di Bologna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA