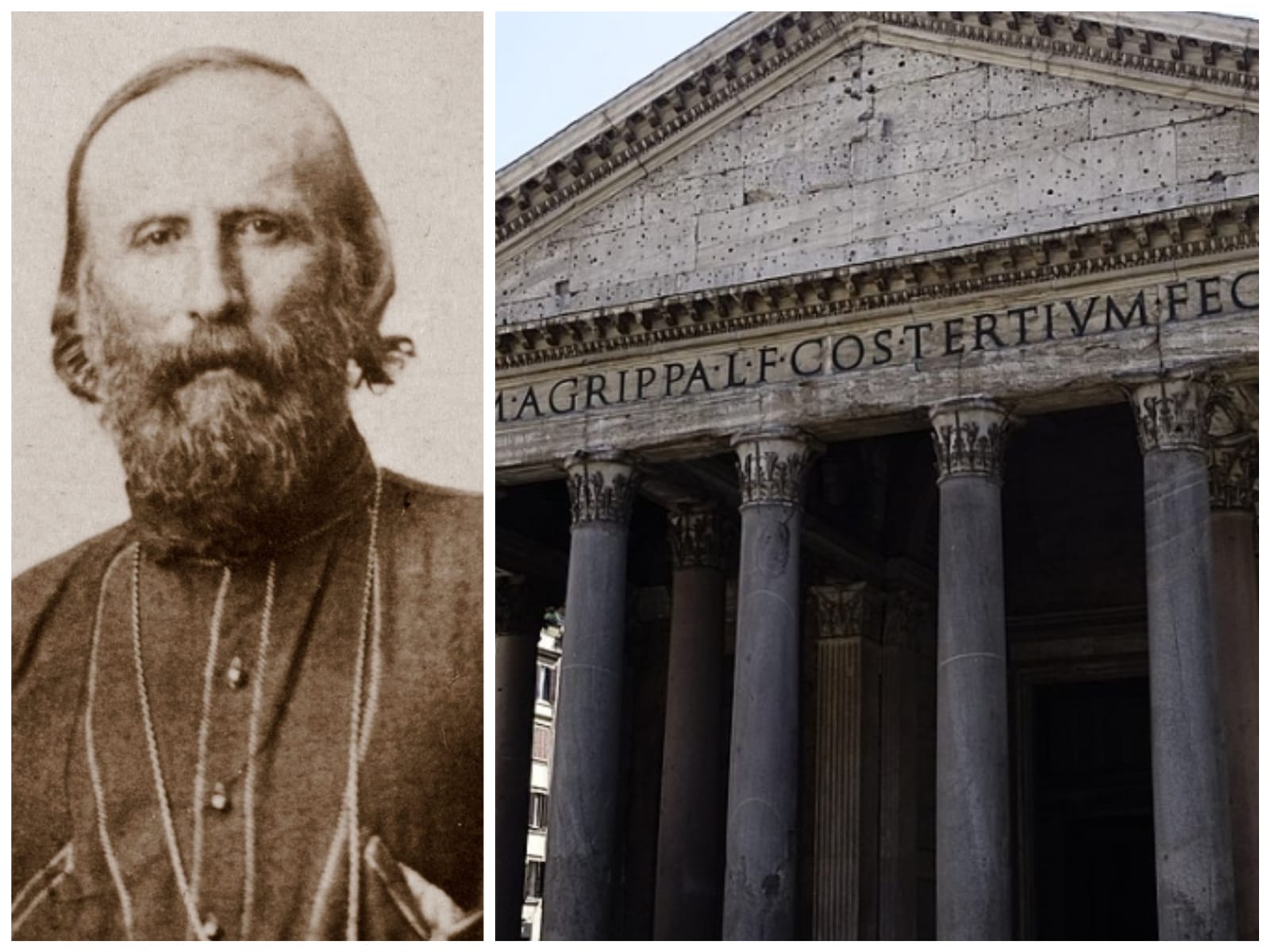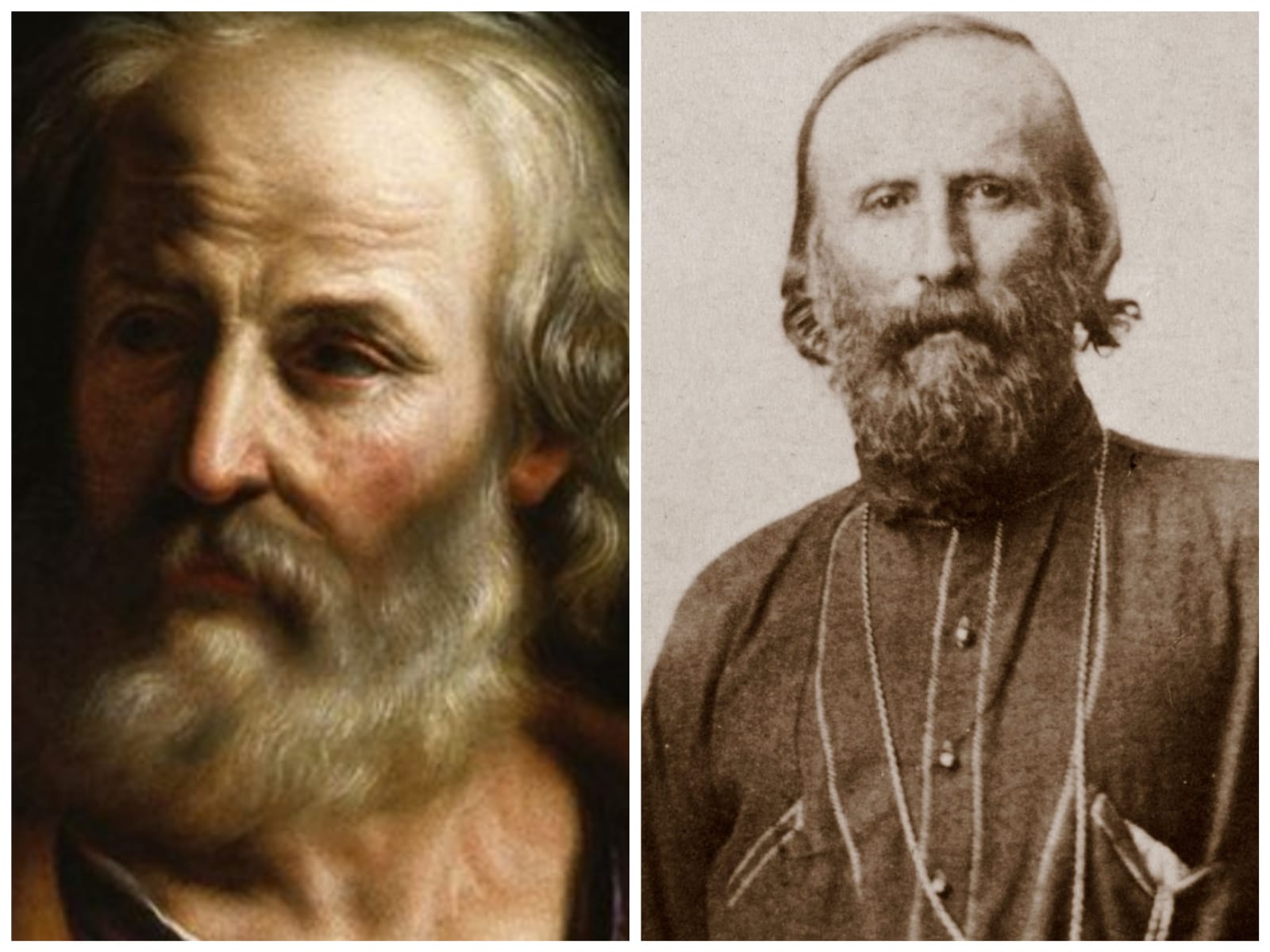Roma VIDEO: alla scoperta dei detti popolari. Che cosa significa “Nun c’è trippa pe gatti”?

Scopriamo in questo nuovo divertente video di Virginia quali sono alcune delle espressioni più famose del dialetto romanesco.
Roma VIDEO: alla scoperta dei detti popolari. Che cosa significa “Nun c’è trippa pe gatti”?
Scopriamo in questo nuovo divertente video di Virginia quali sono alcune delle espressioni più famose del dialetto romanesco.

Perché si dice “Nun c’è trippa pe gatti”? Una frase tipica della parlata romanesca che si è talmente diffusa da averla sicuramente sentita anche in altre parti d’Italia. Dietro questo modo di dire esistono dei risvolti storici, legati indissolubilmente alla città di Roma. Scopriamoli insieme.

Molti dei modi di dire romaneschi sono ormai divenuti parte stessa della lingua italiana. Ma a Roma mantengono quella genuinità che è tipica della Città Eterna e pronunciati da un romano verace assumono una cornice unica, che può avere sulla base del significato tantissime sfumature: ironiche, canzonatorie, ma anche sarcastiche, e talvolta terribilmente tragiche.
Il dialetto romanesco, in effetti, è ricco di esclamazioni, di forme idiomatiche e modi di dire. Succede per molte regioni e città d’Italia ma la parlata romana e i modi di dire romani hanno indubbiamente una originalità tutta loro. Ma veniamo alla nostra frase e perché è così famosa.
L’espressione “Nun c’è trippa pe gatti” viene utilizzata quando, in generale, in qualsiasi situazione, non c’è più niente da fare, quando non ce n’è per nessuno, spesso i romani usano dire che “Nun c’è trippa pe gatti”. Ma chi fu il primo a utilizzarla, tanto da fare scuola?
Questa espressione è attribuita a colui che fu Sindaco del Comune di Roma dal 1907 al 1913: Ernesto Nathan. Il primo cittadino romano di quel periodo rimase famoso soprattutto per i tagli finanziari del bilancio pubblico.
Durante il controllo del piano finanziario del Comune di Roma, Ernesto Nathan notò una spesa chiamata “frattaglie (trippa) per gatti”. Gli fu spiegato che il municipio pagava il cibo per nutrire i gatti che vivevano in città nelle colonie feline.
Tutte le amministrazioni si erano sempre fatte carico di questa spesa, perché mantenere in vita i gatti aveva una funzione ben precisa nel Comune di Roma: i gatti infatti davano la caccia ai topi, pericolosissimi perché divoravano e i documenti cartacei degli archivi. Il compito di dar da mangiare ai gatti era talmente importante da prevedere una figura apposita, il cosiddetto “carnacciaro”.
Ma la cosa non piacque a Ernesto Nathan, che decise di annullare la spesa. Il Sindaco dichiarò che da quel momento i felini avrebbero dovuto nutrirsi con le proprie forze e pronunciò la frase “non c’è trippa per gatti”.
Era il lontanissimo 1907, ma il bilancio del Comune di Roma era già allora in rosso.
Alla Giunta Nathan si devono fra l’altro il primo piano regolatore della città, datato 1909, e l’inaugurazione del Vittoriano, il Palazzo di Giustizia, subito ribattezzato «Il Palazzaccio», della Passeggiata archeologica (oltre 40 mila metri quadrati di verde pubblico tra l’Aventino e il Celio) e dello stadio Nazionale, oggi Flaminio. Oltre a qualcosa come 150 scuole materne.
E Daje?
La notizia dell’arrivo di José Mourinho quale prossimo tecnico della Roma aveva scatenato non solo la tifoseria romana giallorossa ma anche la curiosità dei giornalisti inglesi. L’emittente britannica Sky Sports News, nel riportare la notizia, era andata in difficoltà sulla traduzione e sulla pronuncia di una delle più famose espressioni romanesche, “Daje Roma!”, usata dallo stesso tecnico portoghese per far conoscere la sua decisione sui social. Andiamo a scoprire i numerosi significati di questa espressione ormai molto popolare.

Nella fattispecie, l’espressione, in quel contesto, significa più o meno “Forza Roma”. Il video che mostra la perplessità della giornalista Vicky Gomersall è circolato molto su Twitter e ha provocato un certo divertimento in Italia.
In Italia “daje” è ormai un’espressione che si è diffusa ormai anche tra i non romani: per dire quello che in italiano si potrebbe tradurre con “forza” o “alé”: un incitamento, un incoraggiamento, per invitare qualcuno a fare qualcosa o a reagire con grinta, ma anche per esprimere entusiasmo. A Roma, i contesti in cui viene usato sono comunque tanti ma spesso viene anche utilizzato impropriamente come intercalare (sequenze di suoni che vengono inserite nella frase e nel flusso comunicativo spesso in maniera automatica e irriflessa).
Daje non ha un’origine precisa, perché è semplicemente una forma dialettale romanesca derivata dall’imperativo del verbo “dare”. Perché ha fatto presa anche fuori da Roma e dalla regione laziale? Probabilmente per la sua efficacia e immediatezza, e poi per moda, anche perché il modo di parlare romanesco è da sempre uno dei più rappresentati nel cinema e nella televisione. Daje è quindi un’espressione utilizzata in molte regioni d’Italia anche grazie alla diffusione mediatica e sociale.
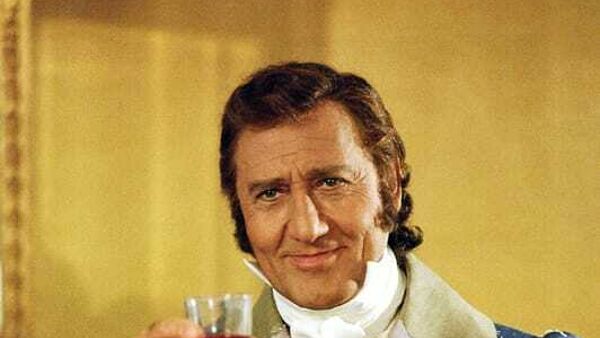
Vediamo meglio nei dettagli: dàje è formato dal verbo dare (a Roma troncato in dà) e dal pronome je, che nel romanesco sta per ‘gli’, ‘le’: vale, quindi, dargli, darle, darci; può essere sia la forma dell’infinito, sia dell’imperativo».
L’espressione usata da Mourinho è la forma imperativa ed esprime incitamento, incoraggiamento, ma non è l’unica accezione di daje. Le altre possono esprimere impazienza, disappunto. In questo caso l’intonazione che si utilizza è diversa, simile a quella di “aridaje”, un’altra espressione che sta sempre a esprimere stizza, fastidio.
Queste accezioni sono documentate dai tempi di Giuseppe Gioacchino Belli, uno dei più noti e importanti autori di componimenti in romanesco che visse nella prima metà dell’Ottocento.
A volte si lega a prefissi e suffissi per assumere connotazioni ulteriori, ad esempio esortative, come nel caso di ed-daje o ari–daje. Oppure è semplicemente un’affermazione di assenso, oppure di soddisfazione, o ancora di gioia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA