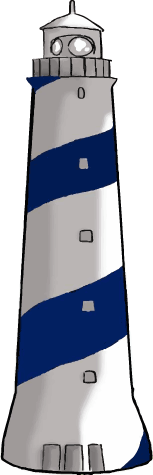La vita in corsia del giovane medico Sandro Monni: «Lo sconforto? Vedersi disumanizzati»

Il villagrandese trentunenne Sandro Monni, al quarto anno di specializzazione, racconta quella che è la vita di corsia, quella vera. Senza sconti. Non indora la pillola, Monni, non rende le cose più sfavillanti. Sì, perché non siamo in Grey’s Anatomy, ma nella vita reale, quella fatta di sudore e di tenacia, soprattutto in questo mondo
Quando c’è da puntare un dito, lo si fa senza pensarci due volte. Senza riflettere, senza ragionare abbastanza. Accusando, sbraitando, arrabbiandosi. Ma mai – o quasi, perlomeno – ci si chiede chi sia il perno del mondo sanitario. Quali siano le sue paure, i suoi momenti di angoscia, le sue cadute, i suoi traguardi, i suoi sorrisi, la sua zattera di salvataggio nei momenti tenebrosi di un mestiere importante, carico di responsabilità, dove non ci sono fermate.
Si parla dei medici che ogni giorno, ogni singolo giorno e spesso con turni massacranti, garantiscono che chi va in ospedale riceva il miglior trattamento sanitario possibile. E lo fanno con grande impegno, con determinazione, nonostante gli insulti che spesso vengono elargiti con sin troppa sicurezza e semplicità, nonostante le giornate grigie – siamo umani, lo sono anche loro, sebbene spesso lo si dimentichi –, nonostante i problemi familiari e i lutti.
«Ho scelto Medicina Interna per una serie di coincidenze temporali e personali che mi hanno portato su questa scelta mai ventilata prima. Io ero orientato sull’Oncologia o sull’Ematologia, specie pediatrica. Ho deciso poi di avere un approccio più generalista e di averlo sull’adulto. Ecco, a quattro anni non so se sia stata la scelta giusta.»
Il villagrandese trentunenne Sandro Monni, al quarto anno di specializzazione, racconta quella che è la vita di corsia, quella vera. Senza sconti. Non indora la pillola, Monni, non rende le cose più sfavillanti. Sì, perché non siamo in Grey’s Anatomy, ma nella vita reale, quella fatta di sudore e di tenacia, soprattutto in questo mondo.
«Ho iniziato la mia attività formativa presso la Medicina Interna del Policlinico Universitario di Monserrato, che continua ad essere luogo prevalente. Ho fatto poi un polo formativo presso la Cardiologia dell’ospedale di Lanusei e un anno di formazione esterna a Roma al Policlinico Gemelli, in Ecografia al CEMAD (centro malattie apparato digerente) e Pronto Soccorso. Ho fatto anche il medico vaccinatore per l’emergenza Covid-19 e ho coperto diversi turni vacanti nelle sedi di guardia medica in Ogliastra, Seui, Perdasdefogu, Tortolì, Baunei, Talana, Bari Sardo.»
Insomma, un curriculum di tutto rispetto per il giovane che, come sottolinea, avrebbe potuto continuare a Roma come dirigente di pronto soccorso – rimanendo lì per concludere la tesi di specializzazione – ma che è tornato nell’Isola per la chiamata della terra madre.
«Non escludo di tornare per un periodo di studio prima della conclusione del mio percorso formativo» continua. «Lanusei è una perla che non difendiamo abbastanza. Ed è un luogo con cui ho un legame profondo.»
Ma cosa significa essere un giovane medico?
«Essere giovane medico oggi vuol dire subire dei meccanismi formativi spesso anacronistici,» spiega «poco attenti al reale raggiungimento degli adeguati skills professionali. Tuttavia è un periodo in cui ci sono, a volte percorrendo le strade concorrente, molteplici opportunità. Tornare alla periferia è una controriforma, una inversione del dogma, di cui la nostra generazione può essere forse capace.»
Meno idilliaca, adrenalinica ed emozionante di quello che uno pensa da fuori: ecco come Monni descrive la vita in corsia. Sì, perché – come abbiamo detto – questa non è la tivù, non ci sono stagioni da seguire, puntate da terminare. «Le Medicine e i Pronto Soccorso sono saturi di grandi anziani a frequente ospedalizzazione che spesso attendono un posto in RSA, oppure vengono ri-accettati a 48 ore dalla dimissione dopo un mese di ricovero Vengono spesso sottoposti a procedure diagnostiche invasive, a lunghe degenze per terapia infusiva, nutriti tramite sondini, gastrostomie o cateteri centrali. Spesso la Medicina si riduce a una gestione della cronicità inevitabile di polipatologie che l’invecchiamento porta con sé.»
Ma non è questo che rende Monni sconfortato, bensì «la rabbia e l’acredine, l’odio, la sfiducia che pazienti e caregiver hanno nei nostri confronti».

«Spesso sono convinti di essere cittadini di serie B, ricevere una sanità di serie B, terapie di serie B. Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli sono persone che avevano tutti i mezzi economici, le conoscenze e l’accesso alle migliori strutture oncologiche europee eppure sono morti a poco più di 50 anni. Le famiglie hanno ringraziato per l’amorevole compassione delle cure prestate. Non un’accusa, non una polemica, non un dubbio. Hanno accettato il loro tragico destino con compostezza e dignità. Ciò cozza tantissimo con quello che vediamo nelle corsie e sui giornali, dove parenti di anziani over 90 con prolungato allettamento, demenza avanzata, cardiopatie strutturali severe, lesioni da decubito, muoiono dopo una lunga degenza complicata. Nonostante le ottimali cure prestate secondo protocollo. Perché morire, a una certa età, è normale. Si cerca sempre una colpa, una lacuna, un errore, un responsabile, ma è normale.»
Ecco, sottolineando le parole del giovane medico, “si cerca una colpa, una lacuna, un errore” quando, in realtà, “morire, a una certa età, è normale”.
Un atteggiamento figlio della nostra epoca che dà per scontato che vivere fino a cento anni sia una regola di tutti. Quando non lo è. Non lo è mai stata. E mai lo sarà.
«Anziché accettare insieme tale esito, potendoci permettere di accompagnare il paziente con dignità e i suoi parenti con conforto, veniamo tacciati di disumanità, “ci doveva essere vostra madre”, “voi non sapete cosa vuol dire”. Questo è lo sconforto. Vedersi disumanizzati» continua. «I momenti gratificanti, purtroppo, sono rari. Sono sprazzi, barlumi. Mi ha fatto commuovere la signora senza figli, prima cantante lirica, che, prima di andare in hospice, cantava le canzoni che aveva imparato nei lunghi anni di Napoli. Napul’e di Pino Daniele, Torna a Suriento. Mi commuove quando un incannulo un bambino a primo colpo e smette di vomitare e di essere disidratato. E mi abbraccia. Mi gratifica quando compio una corretta diagnosi. E il paziente migliora. Mi gratifica quando una paziente che sta attraversando un momento difficile mi dà il privilegio di aprirsi e piangere e raccontarmi, e mi sento importante. E riconosciuto, prima di tutto come persona umana. Mi gratifica quando qualcuno muore con dignità nel conforto di casa sua, tra le mani strette dei suoi cari, ed evitiamo inutili corse in ambulanza, dolorose attese in PS, per paura di denunce. Mi gratifica parlare chiaro, condividere con i parenti una visione, un obiettivo. E morire con dignità, spesso, ce lo dimentichiamo.»
«Tutti i giorni mi chiedo se lo è davvero» risponde, poi, alla domanda sul quando e come abbia compreso che questa era la sua strada.
«Siamo figli, di genitori morti oppure vivi ma pazienti. Siamo noi stessi pazienti stesso. Abbiamo perso qualcuno. Abbiamo paura di sbagliare. È vero. Come tutti. Siamo esseri umani. Questo però è la cosa più importante da ricordare: soffriamo, piangiamo, proviamo angoscia, paura, rabbia esattamente come voi» conclude. «Recuperare l’umanità e la sincerità nell’alleanza di cura nel rapporto medico-paziente è la prima vera emergenza sociale di questo Paese.»

© RIPRODUZIONE RISERVATA