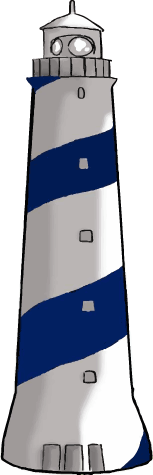La tragedia di Montevecchio: l’8 marzo sardo, in quel tragico giorno morirono 11 lavoratrici

Dieci ore di faticosissimo lavoro, trascorse a spaccare pietre e selezionare il materiale, sotto il severissimo controllo dei caporali. Per chi non lavorava sodo o si perdeva in chiacchiere la pena era la rinuncia alla paga giornaliera. Una paga ben misera e nettamente inferiore rispetto a quella di un uomo, per un lavoro comunque faticosissimo e svolto spesso all’aperto, esposte alle intemperie o al massimo in baracche di fortuna.
Era il 4 maggio 1871 quando, nelle miniere di Montevecchio, 11 donne e bambine morirono a causa del crollo di uno dei dormitori. Le lavoratrici di Montevecchio erano costrette a condizioni lavorative degradanti, nell’assoluta mancanza di ogni tutela e sicurezza. I proprietari degli impianti furono assolti da ogni responsabilità e gli incidenti furono attribuiti ad una “tragica fatalità”. Una tragedia che fa riflettere sul senso dell’8 marzo.
Erano circa le 18:30 quando una trentina di donne e bambine che svolgevano l’attività di cernitrici si ritirarono nel dormitorio di quella che al tempo era la più grande miniera di piombo e zinco d’Europa, a Montevecchio. Dieci ore di faticosissimo lavoro, trascorse a spaccare pietre e selezionare il materiale, sotto il severissimo controllo dei caporali. Per chi non lavorava sodo o si perdeva in chiacchiere la pena era la rinuncia alla paga giornaliera. Una paga ben misera e nettamente inferiore rispetto a quella di un uomo, per un lavoro comunque faticosissimo e svolto spesso all’aperto, esposte alle intemperie o al massimo in baracche di fortuna. Solo chi era veramente costretta dalla povertà accettava simili condizioni di sfruttamento: si trattava di solito di ragazze giovanissime, alcune praticamente bambine, prevalentemente orfane. E poi molte vedove, donne disposte a tutto per sfamare la famiglia.
Dopo la giornata di servizio, le lavoratrici potevano scegliere di non tornare alle proprie case e trattenersi presso il dormitorio della miniera: a disposizione c’erano delle semplici brande in cameroni privi di ogni servizio igienico; ma d’altronde chi prestava lavoro lì aveva da tempo rinunciato a ogni lusso. Sopra il tetto dell’edificio che ospitava le donne era stato costruito un serbatoio di 80 metri cubi d’acqua, necessario al funzionamento della vicina laveria. Durante la notte il serbatoio si ruppe, causando il crollo del soffitto. Le lavoratrici furono schiacciate dalle macerie e undici di loro rimasero uccise.
Dalle carte dell’epoca risulta che le autorità biasimarono la costruzione del bacino proprio sopra al dormitorio, ritenendola decisamente mal sicura. La direzione della miniera rispose scusandosi, ma sostenendo che «non vi era luogo più comodo e adatto» e alla fine la vicenda fu archiviata, senza che la responsabilità dell’accaduto fosse attribuita a nessuno. Per quelle vite nessuno pagò e delle vittime non resta altro che il nome: le più piccole, Elena Aru e Caterina Pusceddu, di Arbus, avevano solo 10 anni. C’erano poi Anna Melis e Anna Atzeni, di 11 e 12 anni; le quattordicenni Anna Peddis e Anna Pusceddu e le quindicenni Rosa Gentila e Luigia Vacca. Un poco più grandi erano invece Luigia Murtas e Antioca Armas, entrambe di Arbus, rispettivamente 27 e 32 anni. Di Guspini invece era la più anziana, Rosa Vacca, di 50 anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA