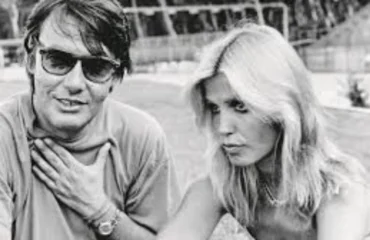Personaggi di Sardegna. Melchiorre Murenu, “l’Omero sardo dei poveri”

La Sardegna aveva il suo "Omero dei Poveri". Era Melchiorre Murenu, poeta cieco e analfabeta che interpretava i disagi e la crisi di contadini e pastori dopo l'Editto delle Chiudende di Carlo Felice.
canale WhatsApp
Nel 1820 il sovrano sabaudo Carlo Felice, succeduto al fratello Vittorio Emanuele, avvia la formazione della proprietà privata della terra sarda, contro il regime di proprietà comune precedentemente prevalente. Si tratta del noto “Editto delle chiudende”, ufficialmente finalizzato alla promozione della crescita dell’agricoltura e della borghesia agraria moderna.
Di fatto, però, la nascita delle cosiddette “tancas”, campi chiusi da siepi o muretti a secco, portò numerosi conflitti fra contadini e pastori, oltre che favorire numerosi abusi e una proprietà assenteista.
Per molti, dunque, fu profonda crisi nel mondo delle campagne. Come riportato da Giovanni Pirodda in “Sardegna – Letteratura delle regioni, storia e testi”, interprete di questi disagi della realtà isolana è stato Melchiorre Murenu, autore rappresentativo dell’uso vivo del sardo nella produzione letteraria orale.
In particolare, la sua vita è simile a quella del più noto Omero, celeberrimo autore dell’Iliade e dell’Odissea, – se tralasciamo la cosiddetta “questione omerica” circa la sua avvenuta esistenza – in quanto errante poeta nelle sagre paesane. Murenu assimilava diversi elementi della tradizione locale e della cultura alta, attraverso l’oralità.
Murenu interpretava con vena moralistica ironica e grottesca gli umori e i disagi dei ceti più umili che subivano gli effetti dell’Editto delle chiudende, tanto da essere noto come “L’Omero dei poveri”. Sempre secondo il Pirodda, il quale riporta una voce corrente, il poeta morì ucciso dai bosani, i quali lo gettarono da una rupe, forse “punti” da qualcuno dei suoi versi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Addio a Giancarlo Farci, anima della Croce Rossa di Cagliari: una vita spesa per gli altri

Cagliari in lutto, addio a Giancarlo Farci: il volontario che ha donato il suo cuore alla Croce Rossa.
canale WhatsApp
Un silenzio carico di commozione attraversa la Croce Rossa di Cagliari per la scomparsa di Giancarlo Farci, volontario stimato e punto di riferimento per colleghi e cittadini. A ricordarlo è un toccante messaggio diffuso dall’associazione, che rende omaggio a una vita spesa al servizio degli altri.
«È difficile trovare le parole quando viene a mancare una persona che ha scelto di donare il proprio tempo, le proprie energie e il proprio cuore agli altri», scrive la Croce Rossa, tracciando il ritratto di un uomo che ha incarnato ogni giorno i valori fondanti dell’organizzazione: umanità, solidarietà e servizio.
Il cordoglio si stringe attorno alla famiglia, agli affetti più cari e a tutti i volontari e colleghi che hanno condiviso con Giancarlo un percorso fatto di impegno, sacrificio e dedizione. «A loro va il nostro più sincero e commosso pensiero», prosegue il messaggio, che sottolinea quanto profondo sia il vuoto lasciato dalla sua scomparsa.
Ma l’eredità di Giancarlo Farci non si spegne. Il suo esempio, il suo instancabile impegno e il bene seminato nel tempo continueranno a vivere nel ricordo di chi lo ha conosciuto e nelle tante vite che ha incrociato con il suo operato. «Ciao Giancarlo, grazie per tutto quello che hai donato. Riposa in pace». Un saluto semplice e potente, che racchiude l’affetto e la gratitudine di un’intera comunità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA