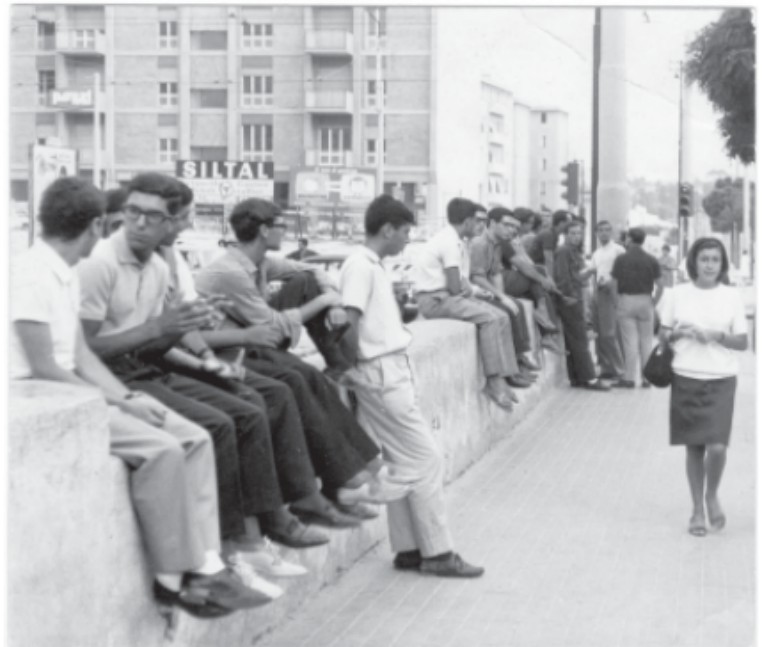Lo sapevate? Quali sono le chiese cristiane più antiche della Sardegna?

Le chiese più antiche della Sardegna non sono San Saturnino a Cagliari e San Giovanni di Sinis. Non tutti sanno che le chiese più antiche dell'Isola si trovano a Cornus, Tharros, Nora e Porto Torres, e sono tutte risalenti agli inizi del V secolo. Di queste chiese, però, troviamo però solo le tracce dei basamenti, quindi poco più che la pianta.
canale WhatsApp
Lo sapevate? Quali sono le chiese cristiane più antiche della Sardegna?
Le chiese più antiche della Sardegna non sono San Saturnino a Cagliari e San Giovanni di Sinis. Non tutti sanno che le chiese più antiche dell’Isola si trovano a Cornus, Tharros, Nora e Porto Torres, e sono tutte risalenti agli inizi del V secolo. Di queste chiese, però, troviamo però solo le tracce dei basamenti, quindi poco più che la pianta.
Tra le chiese che si sono conservate fino ad oggi, invece il primato se lo contendono quelle costruite fra il VI e il VII secolo: le chiese bizantine con pianta cruciforme cupolata, San Saturnino di Cagliari, Sant’Antioco nel centro omonimo e San Giovanni di Sinis a Cabras.
Abbiamo poi le chiese costruite riutilizzando le strutture di impianti termali di età romana: il santuario della Madonna di Bonacattu a Bonarcado, la chiesa di Santa Maria di Mesumundu a Siligo, della chiesa di Santa Filitica a Sorso.
Ci sono poi gli edifici religiosi di piccole dimensioni a pianta cruciforme: Santa Maria Iscalas di Cossoine, San Salvatore di Iglesias, Santa Croce di Ittireddu, Sant’Elia di Tattinnu (Nuxis), San Teodoro di San Vero Congius a Simaxis.
E poi ancora l’oratorio delle Anime a Massama e dello Spirito Santo a Oristano.
Le chiese a croce greca cupolate inscritte in un quadrato: San Giovanni battista di Assemini (che si narra divenne una moschea durante una brevissima occupazione araba)
San Gavino a Porto Torres, invece, è considerata la prima chiesa romanica della Sardegna (impianto basilicale di tipo romano, a doppio abside contrapposto).
Per quanto riguarda la basilica di Nora, la costruzione dell’edificio può essere collocata in un periodo di fermento edilizio che interessò tutta la città di Nora tra il IV ed il V secolo d.C.
La basilica è a pinta longitudinale, del tipo a tre navate con unica abside, precedute da un nartece. Le dimensioni sono notevoli: 33 x 22 m. Il pavimento delle navate e del nartece era lastricato con uno strato sottile di cocciopesto, di fattura non accurata, visto che poggiava direttamente su un battuto di terra. Tra il nartece e le navate vi era una soglia in andesite. I muri esterni avevano uno spessore esiguo, inadatto a sorreggere una volta come copertura, che invece doveva essere a capriate con doppio spiovente. I muri esterni della basilica e le sue fondazioni sono stati realizzati con blocchi di riutilizzo provenienti da altri edifici. La strada si trova ad un livello più basso rispetto a quello dell’edificio. È lecito pensare, pertanto, che si accedesse alla basilica mediante dei gradini, anche se lo stato delle strutture è lacunoso e non consente certezze.
Dal mare emerge solo parte dell’aula, mentre l’abside è sommersa. Al momento della messa in luce, l’edificio fu erroneamente interpretato come pertinente alle strutture portuali. Studi più approfonditi hanno dimostrato che, in realtà, si tratta di una grande basilica con funzione cultuale.
Per quanto riguarda Tharros, in età post-classica a partire forse dal V secolo d.C. si assistette ad una trasformazione degli spazi e ad una riqualificazione dei principali monumenti dovuta alla presenza in città di una rilevante comunità cristiana.
Presso le cosiddette Terme n. 1 appaiono evidenti le ristrutturazioni dovute dall’inserimento di strutture connesse al culto cristiano, nelle quali si è voluto riconoscere la cattedrale e il suo battistero.

Il battistero, a pianta rettangolare, è absidato a N/O. Sono ancora visibili buona parte dell’abside e il tratto del muro perimetrale d., fino all’altezza della piscina, entrambi in grossi blocchi squadrati. Il pavimento è in lastre di basalto. La piscina, scavata nella roccia, è profonda m 0,78, ha forma esagonale e risulta rivestita con cocciopesto e definita sul bordo da lastre di basalto e arenaria. Sul lato N del fonte rimangono due capitelli di ordine dorico, riutilizzati capovolti come basi di colonna, pertinenti ad una probabile copertura a baldacchino. Tra le due basi è presente, inoltre, un manufatto in arenaria e muratura, che è stato interpretato come cattedra episcopale.
La vasca esagonale, per la sua tipologia, permette di confrontare il battistero con analoghe strutture dell’area tunisina e algerina, delle Baleari e della Gallia. L’analisi del battistero e della vasca battesimale consentono di datare l’edificio tra la fine del V e la prima metà del VI secolo.
Per quanto riguarda la cattedrale, permangono ancora forti dubbi sulla sua individuazione. Si ritiene, infatti che l’avanzare della linea di costa abbia cancellato gran parte della basilica, di cui si conserva solamente il muro perimetrale O realizzato con blocchi di arenaria.
A Cornus venne realizzata una basilica funeraria absidata con pianta mononavata, due absidi concentriche a Nord e cinque vani contigui. Tra la fine del V e l’inizio del VI secolo d.C. nella basilica venne creato un breve corridoio trasversale che dava accesso al mausoleo quadrangolare, mentre nell’angolo Sud-Est fu realizzato un vano provvisto di una vasca, ovale esternamente e rettangolare nel perimetro interno, individuato come vasca battesimale minore.
La basilica funeraria comunicava con il complesso episcopale che si sviluppò più a Sud tramite un ampio cortile; verosimilmente venne predisposto un percorso al fine di garantire il collegamento tra queste zone e la necropoli sorta ad Est.
Tra la seconda metà del IV e l’inizio del V secolo d.C., a Sud della basilica funeraria, vennero edificate due aule di culto parallele e comunicanti, ma con orientamento opposto: una maggiore, cosiddetta “episcopale”, era il luogo preposto per la liturgia ordinaria, mentre quella meridionale, di dimensioni inferiori, era esclusivamente destinata allo svolgimento dei riti connessi al battesimo.
La cattedrale era caratterizzata da nartece, tre navate, abside sopraelevata – con cattedra rialzata – inclusa in un muro rettilineo e affiancata da due pastophoria.
L’altare, invece, era situato in posizione mediana nella navata centrale ed era in origine sormontato da un ciborio.
La chiesa battesimale era connotata dall’abside ad Ovest, dalla pianta trinavata, da un ingresso ad oriente poi tamponato e da un fonte battesimale.
La struttura subì importanti mutamenti tra la fine del V e la prima metà del VI secolo. L’abside della basilica venne fiancheggiata da due pastofori: l’ambiente di servizio destro (diaconicon) si caratterizzava per la presenza di un’apertura che garantiva l’ingresso alla chiesa ai battezzandi; vennero creati nuovi ambienti, il fonte battesimale diventò poligonale. Inoltre fu realizzato un nuovo percorso per i neobattezzati diretti nella basilica maggiore. Contemporaneamente l’area cimiteriale venne ampliata verso Sud. Nei secoli successivi l’area fu interessata da un’incendio che provocò danni ingenti e venne abbandonata.
A Porto Torres furono costruite due antiche basiliche (una delle quali, a pianta centrale, era il Martiryon costruito sulla tomba di san Gavino, i cui resti furono inglobati nella cripta della basilica) databili tra il V-VII secolo. I resti furono inglobati nella cripta della basilica: lo dimostrarono varie campagne di scavo archeologico che individuarono i residui murari di due chiese più antiche. Una, più piccola, sta sotto il fianco N della basilica romanica, l’altra si estende nel settore esterno N. Erano entrambe a tre navate ma la più piccola aveva l’abside a O, l’altra a E.

© RIPRODUZIONE RISERVATA