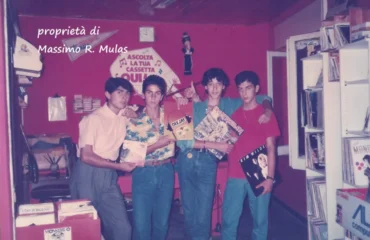Il segreto della longevità sonora: perché il Canto a Tenore resiste al tempo ed è un tesoro Unesco

È un fenomeno unico, un coro di voci primordiali che non si limita a risuonare, ma vive tra le pieghe della storia e dell'identità sarda. Il Canto a Tenore, l'espressione musicale più tipica della Sardegna.
canale WhatsApp
Il segreto della longevità sonora: perché il Canto a Tenore resiste al tempo ed è un tesoro Unesco.
È un fenomeno unico, un coro di voci primordiali che non si limita a risuonare, ma vive tra le pieghe della storia e dell’identità sarda. Il Canto a Tenore, l’espressione musicale più tipica della Sardegna, non è solo un’arte: è la trasposizione sonora del mondo agro-pastorale, un codice antichissimo che l’UNESCO ha elevato a patrimonio immateriale dell’Umanità. Sebbene le sue origini siano misteriose e scarsamente documentate, sono di certo antichissime, e la sua eco si spinge dai monti della Barbagia agli altopiani del Marghine e della Planargia, fino ai Tacchi d’Ogliastra e alle vallate del Montiferru, toccando i paesaggi granitici della Gallura e le colline del Logudoro.
Il Tenore indica sia il canto stesso, sia il gruppo di quattro voci che lo esegue, rigorosamente in piedi e in circolo. La performance è una dimostrazione di simbiosi con la natura, le cui voci sono imitate dalle singole parti. Il canto è guidato da sa oche (o boghe), il ‘solista’, che ha il compito di interpretare il testo poetico e di fornire ritmo e tonalità. Attorno a lui, le altre tre voci creano un fondamento sonoro quasi ancestrale. La nota base è tenuta da su bassu, con un suono gutturale e vibrato, che si unisce a sa contra: insieme cantano monosillabi nonsense. Infine, l’elemento di finezza e virtuosismo è sa mesu oche (o boghe), l’unica a variare continuamente la melodia e ad arricchirla con sas giradas, attenuando l’asprezza dei suoni gutturali. Gli argomenti in questione spaziano dalla poetica bucolica e amorosa ai temi sociali e all’attualità, mantenendo sempre le caratteristiche immutabili della tradizione.
Il vero tesoro del Canto a Tenore risiede nella sua regionalizzazione. Per indicare questa arte, infatti, i nomi variano e ogni paese ha sviluppato un suo preciso ‘codice’, noto come su trattu. La differenza non è solo lessicale – si va da cussertu a Mamoiada e in alta Baronia, a cuncordu nella Barbagia di Ollolai, a Neoneli e a Santu Lussurgiu, fino a cuntrattu a Seneghe e ad Abbasanta – ma anche timbrica e stilistica. Uno dei motivi che rendono affascinante su tenore sta proprio nel cogliere le diverse sfumature da paese a paese. Attorno al Supramonte, per esempio, a Orgosolo e Oliena, il canto si intona con sillabe aperte. Nei dintorni di Orune, invece, le sentirai più chiuse e rotonde, dando all’ascolto l’effetto di un canto più cupo. Esistono tre tipi di canti: il canto a boghe ‘e notte, forse tratto dalle serenate notturne, quello a muttos, con temi amorosi o umoristici, e quello a boghe ‘e ballu, destinato ad accompagnare i balli tradizionali.
Le occasioni per ascoltare il Canto a Tenore sono molteplici e spaziano dall’informale al sacro. Si possono ascoltare le quattro voci durante i raduni tra amici in sos tzilleris, i bar dei piccoli borghi, o a chiudere i momenti conviviali noti come sas rebottas, cioè gli spuntini a base di prodotti tipici. Non mancano le occasioni ‘ufficiali’, come sagre, feste religiose e rassegne culturali nei paesi dove la tradizione è più viva. Per un’esperienza di “immersione” totale, a Bitti è stato allestito il museo multimediale del Canto a Tenore. Grazie a strumenti multimediali, il visitatore potrà comprendere la complessità armonica, ascoltare le singole voci, osservare le esibizioni dei gruppi, e persino imparare i passi dei balli che accompagnano sos cantusu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA