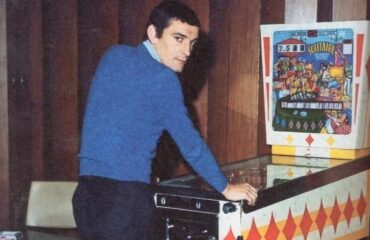Lo sapevate? Sino al secolo scorso in Sardegna viveva l’aquila di mare

L’aquila di mare, regina perduta dei cieli di Sardegna. L’aquila di mare (Haliaeetus albicilla) è uno dei rapaci più imponenti e affascinanti che si possa avere la fortuna di osservare nei cieli d’Europa, un predatore maestoso dal volo lento e possente che un tempo popolava vaste aree del continente.
canale WhatsApp
Lo sapevate? Sino al secolo scorso in Sardegna viveva l’aquila di mare.
L’aquila di mare, regina perduta dei cieli di Sardegna. L’aquila di mare (Haliaeetus albicilla) è uno dei rapaci più imponenti e affascinanti che si possa avere la fortuna di osservare nei cieli d’Europa, un predatore maestoso dal volo lento e possente che un tempo popolava vaste aree del continente.
In Italia, questa specie ha conosciuto una parabola drammatica: diffusa per secoli nelle zone costiere e umide, è progressivamente scomparsa fino a estinguersi come nidificante nella seconda metà del XX secolo, una perdita che ha privato il nostro Paese di uno dei suoi simboli più suggestivi della natura selvaggia. Eppure, se oggi guardiamo alla sua storia, non mancano motivi di speranza.
La Sardegna ha rappresentato il cuore del suo areale italiano e l’ultimo avamposto a cedere. All’inizio del Novecento diverse decine di coppie erano ancora presenti lungo le coste meridionali, nell’Oristanese e in Ogliastra, territori ideali grazie alle lagune, alle foci dei fiumi e agli specchi d’acqua che garantivano abbondanza di pesce. Ma la convivenza con l’uomo si rivelò fatale: il bracconaggio, la progressiva perdita di habitat e soprattutto l’uso massiccio di pesticidi, che riducevano le risorse alimentari e contaminavano la catena trofica, portarono in pochi decenni alla scomparsa di ogni nidificazione. La stessa sorte toccò alla vicina Corsica, con l’unica differenza che il falco pescatore, a differenza dell’aquila di mare, riuscì a sopravvivere a quella fase critica. Da allora, in Sardegna come nel resto d’Italia, la presenza della specie è rimasta confinata a sporadici avvistamenti, legati a individui provenienti dai Paesi nordici durante le migrazioni o lo svernamento.
Nonostante questa assenza, la storia dell’aquila di mare non si è fermata. L’Europa orientale racconta un percorso diverso, che mostra come tutela e lungimiranza possano cambiare il destino di una specie. Un esempio emblematico arriva dalla Romania, dove il Delta del Danubio ha visto un declino altrettanto drastico. Negli anni Cinquanta la zona contava 38 coppie nidificanti, ma nel 1987 erano rimaste appena sei. L’uso di pesticidi, il piombo dei proiettili, il disturbo umano e il bracconaggio sembravano aver condannato la specie a una scomparsa definitiva anche da lì.
La svolta avvenne nel 1990 con l’istituzione della Riserva della Biosfera del Delta del Danubio. Grazie alla protezione dell’area, al divieto di caccia e alla crescente attenzione scientifica, l’aquila di mare ha potuto lentamente riprendersi. I dati parlano chiaro: dalle 21 coppie censite nel 2009 si è arrivati agli 80 nidi attivi di oggi, distribuiti in habitat diversificati che spaziano dalle foreste ripariali alle torbiere, dai canneti ai terreni agricoli a basso impatto. Una dimostrazione evidente di resilienza e adattamento, resa possibile solo dalla tutela di un mosaico ecologico vario e ben conservato.
Gli studi hanno anche permesso di comprendere meglio le preferenze ecologiche della specie. La maggior parte dei nidi si trova su Salix alba (64%), seguito dal Populus alba (21%) e dal Populus x canadensis (9%), con altezze variabili dai 5 ai 24 metri, anche se con una predilezione per le chiome più elevate. Questi dettagli confermano la capacità dell’aquila di mare di adattarsi a condizioni diverse, purché sia garantito un ambiente ricco di prede e libero da disturbi eccessivi.
Il caso del Delta del Danubio dimostra che la conservazione mirata, la riduzione dell’impatto umano e la sensibilizzazione delle comunità locali possono invertire anche le tendenze più drammatiche. Non è solo un successo per gli ambientalisti, ma un messaggio universale: proteggere un grande predatore significa proteggere l’intero ecosistema. L’aquila di mare non è soltanto un simbolo di bellezza e potenza, ma un indicatore prezioso dello stato di salute degli ambienti naturali.
Guardando a questo successo, la domanda sorge spontanea: potrà un giorno tornare a volare stabilmente anche nei cieli italiani e sardi? Per ora restano soltanto ipotesi e sogni, ma ciò che appare certo è che senza un impegno concreto nella tutela degli habitat, nel contrasto al bracconaggio e nel contenimento dei pesticidi, la speranza rischia di rimanere tale. Eppure la lezione del Danubio insegna che, con la volontà politica e sociale, persino una specie data per persa può riappropriarsi del proprio spazio.
In Sardegna, dove sino al secolo scorso l’aquila di mare dominava le coste e i cieli, resta la memoria di un legame profondo e perduto. Ma la natura, quando protetta, sa riscrivere la propria storia: e forse un giorno, tra le lagune e le falesie dell’isola, non sarà più un ricordo, ma di nuovo una realtà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA