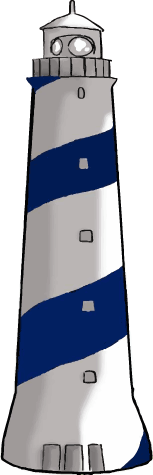Sconfigge il Sarcoma di Ewing e vive felice, la storia di Roberta Marongiu: «La sofferenza mi ha resa quella che sono»

Ha appena compiuto diciotto anni quando un ciclone chiamato Sarcoma di Ewing si abbatte sulla sua esistenza: da allora, tante sono le battaglie. La storia di Roberta Marongiu e del suo amore per la vita.
La vita è imprevedibile e spesso mette dinanzi a tutti noi degli ostacoli che sembrano insormontabili. Dicono che grazie al dolore si possa comprendere la gioia, che l’esistenza sia proprio un’altalena tra problemi e momenti di serenità e che dopo la tempesta arrivi sempre il sereno, ma questo concetto è un po’ particolare: è consolatorio per alcuni, per altri che stanno vivendo un periodo molto duro no.
Oggi vi raccontiamo la storia di Roberta Marongiu, 41enne che tanti anni fa, appena maggiorenne, ha combattuto per poi sconfigger – non senza tantissime peripezie, tanti pianti e dolore ma anche tanto, immenso coraggio – il Sarcoma di Ewing.
«Ancora oggi porto i segni visibili e non di ciò che ho passato, sono felice di quella che sono e che sono diventata nel tempo: è come se avessi veramente vinto una guerra con i segni tangibili della battaglia, anche perché tanti non hanno avuto la mia stessa fortuna di poterlo raccontare. Chi conosce bene il Sarcoma di Ewing, mi dice di essere una miracolata.»
Ma facciamo un salto indietro. Roberta nasce a Torino, ma a 10 anni si trasferisce a Teulada, paese d’origine di mamma e papà. Si sente un po’ persa, abituata com’era stata fino ad allora all’estate sarda, ma tutto va piuttosto bene.
Poi, il destino si mette contro di lei in un’età particolare. I diciotto anni, che età! Si è maggiorenni, ma si è ancora bambini. Si sogna l’indipendenza, ma si ha ancora bisogno del sostegno dei propri cari. È un’età bellissima e inquieta insieme, che si ricorda per tutto il resto della vita come una delle più affascinanti.
«Sono passati ormai 22 anni da quando la mia vita è stata letteralmente stravolta da un male chiamato Sarcoma di Ewing, ma faccio un breve preambolo. Era l’estate del 2000, quando appena compiuta la maggiore età, ho deciso di trascorrere la mia estate lavorando e ho fatto la mia prima (e ultima) stagione lavorativa, perché avevo deciso di mettere da parte un po’ di soldi per prendere la patente, l’anno successivo, una volta terminati gli studi e poi partire per andare a cercare lavoro fuori dalla Sardegna.»
Così comincia la quinta superiore e Roberta ha un obiettivo: neppure un giorno di assenza, in modo da terminare gli studi nel migliore dei modi.
«Decisi di farmi un regalo con l’ultimo stipendio ricevuto e mi comprai un bellissimo paio di stivali. Qualche mese dopo, decisi di indossarli per la festa di chiusura della stagione lavorativa e mi resi conto che uno risultava più stretto. Ho sempre avuto la fissa delle scarpe, da quando ero piccolissima, la cosa mi innervosiva moltissimo addirittura avevo pensato di aver acquistato il numero diverso dello stivale. Togliendomelo, mi resi conto, invece, che il problema era nella mia caviglia, che non era gonfia, ma aveva proprio una protuberanza, una sorta di palla.»
Pur non essendo abituata ad andare dal medico, Roberta va, pur non sentendosi preoccupata: le viene prescritta un’ecografia che però necessita di un altro esame. La ragazza fa anche una risonanza tramite il dottor Lostia, ortopedico molto conosciuto, ma anche questa non è sufficiente a dirimere i dubbi: serve una biopsia.
«Il dottor Lostia mi seguì passo passo e decise di farmi fare l’esame a Firenze presso l’ospedale Careggi, dove lui era in contatto con un suo collega ortopedico.»
Parte per Firenze a marzo 2001, dopo la biopsia torna a casa più serena: «Ci dissero che dall’aspetto non sembrava nulla di preoccupante e al 99,9% era qualcosa di benigno e che, se entro 15 giorni non avremmo ricevuto nessun tipo di contatto da parte loro, ci saremmo sentiti dopo l’estate per valutare un intervento di asportazione.»
Ma il 21 marzo, dodici giorni dopo la biopsia, a casa Marongiu suona il telefono. Roberta ha uno strano presentimento, si è alzata con una sensazione strana.
Purtroppo, quel giorno un macigno si posa sul suo cuore. «Mio padre arriva con le lacrime agli occhi, mi guarda e mi dice: “Hai un tumore, un Sarcoma di Ewing”. Ecco che il mondo mi crolla addosso e la domanda è “Perché? Perché a me?” Urla, pianti, confusione totale, arrivano tutti, mia mamma, mia nonna, le mie zie. Al veder piangere i miei genitori, ho pensato “Puoi farli star male così?”, la risposta “NO” ed ecco che decido di lavarmi, vestirmi e recarmi a scuola a comunicare ai miei compagni che cosa mi stava accadendo, cosa avrei dovuto affrontare e che comunque all’esame ci sarei stata anche io con loro. Pianti, abbracci e poi via, la vita continua.»
Il primo aprile del 2001 si parte, direzione Pisa, per la chemioterapia
«Chiedo al medico: “Ok, ora mi dice che è un pesce d’aprile e ci ridiamo su”, il medico mi risponde “Mi farebbe piacere”, invece chiede di parlare prima con i miei genitori e poi con me, dato che, anche se ero ricoverata in un reparto di oncologia-pediatrica (fortunatamente), ero già maggiorenne.»
Tre le strade possibili: «Inizio di un protocollo con chemio, radio e autotrapianto di cellule staminali (che eventualmente sarebbe stato modificato in base alla risposta del mio corpo alla terapia), l’amputazione dell’arto o la morte. Bene e pensare che mi volevo diplomare, prendere la patente e partire per cercare lavoro, proprio la stessa cosa.»
Ma Roberta è perentoria con il medico: seguirà alla lettera tutto, ma solo se le verrà consentito di diplomarsi a giugno.
Poco dopo il primo ciclo, per Pasqua Roberta inizia a perdere i capelli. «Seppur dispiaciuta, decido di rasarli, mi guardo, piango come una disperata, ma dopo mi rendo conto che i capelli ricresceranno, forse è un modo per sfogare la rabbia. Devo mettere il catetere venoso centrale per poter continuare perché la chemio mi sta bruciando le vene. Continuo gli studi e quando sono a casa, dato che viaggio solo con la mia mamma, che tra parentesi odiava gli aerei, e faccio 10 giorni a Pisa e 10 giorni a Teulada, mi organizzo per andare a dare le interrogazioni per poter essere ammessa all’esame. Tutti i professori sono disponibili e carini nei miei confronti, vengono a casa per darmi lezioni che non posso seguire a scuola oppure sono io che vado da loro.»
Al terzo ciclo, ahimè, Roberta viene ricoverata d’urgenza per setticemia.
«È qui che conosco il dottorino del mio cuore, Dottor Giulio Murgia, un raggio di sole in una situazione completamente buia. Mi spiega tutte le cose, come leggere le analisi e come comportarmi affinché tutto proceda nel migliore dei modi.»
Dopo il quarto ciclo, arriva l’esame di maturità ma non sia mai che manchino intoppi e quasi Roberta rischia di perdere il suo sogno. Il 20 giugno però, con un coraggio incredibile, fa tutte le prove scritte, prosegue con l’orale e si accaparra un bellissimo e meritatissimo 85/100.
«Parto per l’intervento di asportazione del mio amico Ewing e poi devo continuare con gli altri 5 cicli di chemio, la radioterapia e l’autotrapianto di cellule staminali, che mi vengono prelevate tra il 5° e il 6° ciclo, durante l’estate. Sembra tutto interminabile, arriva l’ultimo ciclo in camera sterile per procedere alla parte più complicata, azzeramento del midollo e autotrapianto, che dovrebbe andare a buon fine dato che le cellule staminali sono le mie, ma la ripresa potrebbe essere più o meno lunga, naturalmente tutto questo avviene dal 10 dicembre al 10 gennaio, quindi ennesima festività trascorsa in ospedale. Ora il mostro è stato decisamente sconfitto.»
A gennaio 2002 tutto sembra tornato alla normalità e l’unico obiettivo è riprendersi da quella batosta, dimenticare quei lunghissimi mesi trascorsi tra paura e speranza. Ma ancora il fato deve giocare una carta.
«Nella caviglia dove c’era il mio amico Ewing e dove ho fatto la radioterapia, si crea un’ulcera, come una bruciatura da forno, e quindi si ricomincia con l’ospedale. Il dolore è atroce e oltre agli impacchi e alle garze per le ustioni non posso fare altro, ho provato anche con infiltrazioni di fattori di crescita, ma niente. Vado a fare la visita di controllo a Firenze e mi dicono che a breve mi chiameranno per l’intervento per impiantare una parte della pelle, presa dalla mia coscia, sulla caviglia, ma nel frattempo devo fare della camera iperbarica, l’unica cosa che finalmente allevia il mio dolore.»
Da settembre 2002, Roberta viene chiamata a maggio 2003, esattamente il giorno del suo compleanno: dovrebbe, così pare, cavarsela tra intervento e post-intervento in 15 giorni ma il dodicesimo giorno, quando chiede della dimissione, trova facce strane e sguardi ambigui. «La pelle non ha attecchito, c’è un rigetto e sta andando tutto in necrosi.»
Da maggio a luglio rimane ricoverata, poi ad agosto viene dimessa con ricovero programmato a settembre per fare un altro tentativo di innesto di cute.
«Rientrata a Teulada, ero abbastanza preoccupata per la situazione e decido di rivolgermi ai medici che mi avevano seguito in camera iperbarica. Risultato? Con lo stupore di tutti, si scopre che ho una gamba in necrosi e, se non mi faccio ricoverare in tempi brevissimi, nella migliore delle ipotesi il sangue va in setticemia e rischio di morire e nella peggiore delle ipotesi rischio l’amputazione della gamba. Ci risiamo, nuovamente una scelta difficile, ma obbligatoria.»
Da luglio a ottobre 2003 Roberta si fa ricoverare in chirurgia della mano.
«Mi curano, mi salvano la gamba e mi rimettono in sesto. Dopo la dimissione, fino al 2005 entro ed esco dall’ospedale, alle volte in day hospital e altre volte in regime di ricovero, ma finalmente ricomincio a camminare prima con le stampelle e poi da sola e solo nel 2006 posso cominciare a pensare a qualcosa di concreto per il mio futuro.»
Comincia con piccoli lavoretti: del resto, è ancora dentro l’incubo e la paura di fare progetti a lunga scadenza la spaventa, la atterrisce.
«Dopo la prima vittoria, dalla quale ancora non ero completamente uscita, sono stata nuovamente travolta da un ciclone che nessuno aveva preventivato e che mi ha colto impreparata.»
Ma cosa lascia questo percorso?
«Cose belle e cose brutte» racconta. «Mi ha fatto conoscere tante persone, grandi e piccine e da tutti ho imparato qualcosa. Dai genitori (compresi i miei), che dovevano mascherare il loro dolore dietro grossi sorrisi, che dietro le porte, lontano dagli occhi indiscreti dei figli, diventavano lacrime, lacrime a fiume. Dai più piccolini, che vivevano la malattia con molta spensieratezza e con la rabbia di chi, rinchiuso in una stanza di ospedale, non poteva fare le stesse cose dei loro coetanei, ma che passava, con il clown dell’ospedale, con il giochino premio comprato per non aver fatto troppe storie per le medicine da prendere, la terapia da seguire, il prelievo da fare, con un cartone animato, con l’incontro in reparto con altri bambini nella stessa situazione e dove il dialogo non era fatto, come per gli adulti, di che terapia avevano fatto in quel giorno, ma del gioco comprato o da comprare per essere stati bravi.»
E non solo.
«Con la malattia ho capito chi sono i veri amici e chi quelli che si dichiaravano tali, ma che al momento del bisogno sono spariti. Non ho dovuto fare io una cernita e tagliare i rami secchi, ma è stato tutto molto naturale e seppur all’inizio abbia sofferto, dopo ho capito che questa è stata una fortuna perché di certe persone non te ne fai nulla. Forse, nonostante tutto, ad oggi mi rimangono prevalentemente bei ricordi, anche perché ero sempre accompagnata dalla mia mammina che oggi non c’è più, e con la quale ho vissuto uno dei periodi più duri che una persona possa affrontare che ci ha unito ancora di più. Avevo accanto mio padre e la mia famiglia (nonna, zia, madrina di cresima e di battesimo), ho conosciuto un sacco di persone bellissime che probabilmente non avrei conosciuto. Forse senza questo percorso, non sarei la Roberta che sono, non so come sarei stata, ma la Roberta di oggi a me piace e se anche so che non posso piacere a tutti a me va bene così.»
Roberta oggi è socievole, felice, sempre disponibile quando qualcuno ha necessità e – soprattutto – sa qual è la vera sofferenza quindi sa prestare supporto alle persone che ne hanno bisogno, sa ascoltare, capisce le difficoltà degli altri, ma sa anche allontanare da sé le cose e le persone di cui non ha bisogno e che non la fanno star bene perché, dopo tutto quello che ha passato, non ha bisogno di ciò che le può portare altra sofferenza, l’ha già vissuta abbastanza.
«Mi occupo principalmente di informatica nell’ambito sanitario, ironia della sorte, mi piace molto aiutare le persone, però alle volte la mia empatia è un’arma a doppio taglio. Ho tanti interessi, la cucina, la palestra, il trucco, l’estetica, il ballo, la fotografia, i viaggi…. Vado un po’ a periodi e dovrei avere giornate di 48 ore per poter fare tutto ciò che mi piace. Ho 5 gatti che amo e che vivono con me in casa, i primi due li ho scelti, ero in un periodo particolare della mia vita, dove avevo bisogno di occuparmi di qualcuno per evitare di pensare e 3 li ho salvati 2 anni fa da morte certa, li ho dovuti allattare ogni tre ore, curare da varie e non gravi malattie, sopravvenute perché non sono cresciuti con la loro mamma, ma oggi sono 3 gatti belli e sani.»
Nel 2013, la sua mamma – e la sua roccia in quel periodo così duro – lascia la terra anche lei per un tumore, questa volta all’esofago.
«È come se avesse fatto un patto, diceva sempre: “Se Dio ti salva, una volta che so che stai bene, sei sistemata in ogni campo (salute, lavoro ecc.) può prendere me in cambio perché so di andarmene tranquilla”, e così è stato. Ma la sento sempre con me, anche se ogni tanto mi chiedo se sarebbe fiera di me e delle mie scelte… Essendo figlia unica ora ho solo mio padre che mi ama per due e che ha sofferto tanto per la morte di mia madre, anche se non ha mai voluto darlo a vedere troppo, ma è stata il suo primo ed unico amore e avrebbe preferito andare via lui, ma la vita è imprevedibile. Li amo entrambi, mi hanno dato la vita, mi hanno salvato e non mi hanno fatto mai mancare nulla.»

© RIPRODUZIONE RISERVATA