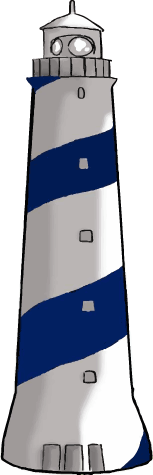Accadde oggi. 28 maggio 2007, “Titti so, so in Sedilo, mì che so fuidu”: la fine del sequestro Titti Pinna

Un uomo si presentò intorno alle nove all’ingresso dello stabilimento industriale GMC di Sedilo, in provincia di Oristano, un’azienda che lavora il basalto e il granito. Barba e capelli lunghissimi, abiti ridotti a brandelli, trenta chili in meno. «Sono Titti Pinna, datemi da bere»
Era la mattina del 28 maggio 2007 – esattamente dieci anni fa. Un uomo si presentò intorno alle nove all’ingresso dello stabilimento industriale GMC di Sedilo, in provincia di Oristano, un’azienda che lavora il basalto e il granito. Barba e capelli lunghissimi, abiti ridotti a brandelli, trenta chili in meno. «Sono Titti Pinna, datemi da bere». Ancora le catene ai polsi. I primi a soccorrerlo furono gli operai della cava che avvertirono le forze dell’ordine, giunte qualche istante dopo. Il setto nasale rotto, probabilmente dalla sera del rapimento. Proprio in quelle ore nella zona era in corso una battuta per la ricerca dell’allevatore di Bonorva.
Non con il pagamento del riscatto, né con il rilascio, ma con la fuga: così in quella mattina di maggio finiva un incubo durato otto lunghissimi mesi. L’imprenditore zootecnico, Giovanni Battista Pinna – noto Titti – riuscì, infatti, a scappare dalla sua prigione, un ovile che si trova proprio di fronte alla cava. L’assenza – pare voluta – dei suoi carcerieri e una forchetta per allargare il fili che bloccavano le catene ad una base di ferro furono le chiavi con cui Pinna ritrovò la sua libertà. Una manciata di secondi per rivedere la luce, dopo 251 giorni di buio assoluto, trascorsi senza potersi muovere, legato, con le bende agli occhi e una catena al collo, in un buco nero. Fu in questo modo che si chiuse il giallo del suo sequestro.
L’allevatore, all’epoca trentasettenne, era stato prelevato dall’azienda di famiglia a “Monti Frusciu” nella periferia di Bonorva, un piccolo paese in provincia di Sassari, nel pomeriggio del 19 settembre 2006. I ladri di uomini ritornavano dopo una lunga assenza, per rubare ancora una volta. E quel sequestro di persona, pur anomalo, specie per l’esigua richiesta di riscatto, costrinse la Sardegna a rileggere la cronaca del passato.
‹‹Mi hanno preso, preparate 300000 euro, sennò mi ammazzano››. Fu lo stesso ostaggio a telefonare alla sua famiglia la sera del rapimento. Una seconda telefonata, questa volta dei rapitori, partì da una cabina telefonica di Nuoro per confermarlo. Immediate furono le ricerche, dal Meilogu al Nuorese per scovare il nascondiglio, ma nulla, di Titti nessuna traccia. Solo la sua auto – usata dai banditi per la prima parte della fuga – comparve due giorni dopo nei pressi di Foresta Burgos, a più di venti chilometri da Bonorva.
In quello che iniziò come un sequestro-lampo seguiranno un incontro fallito con gli emissari dei rapitori, tentativi di depistaggio, nuove ipotesi – si pensò addirittura ad una fuga volontaria in Romania – gli appelli incessanti della famiglia, quelli del comitato spontaneo “Titti Libero” e quello del Papa Benedetto XVI. Sullo sfondo il mistero e il timore per le sorti dell’allevatore.
Poi il silenzio piombò sulla vicenda, fino a quella mattina. Una voce, quella di Titti, lo interruppe. «Titti so, so in Sedilo, mì che so fuidu (sono Titti, sono a Sedilo, sono fuggito)». Queste le parole che l’ormai ex ostaggio rivolge alla sorella, Maria Margherita Pinna, nella sua prima telefonata da uomo libero, pochi istanti dopo la fuga.
Segregato nell’ovile di “Su Padru”, in quelle campagne di Sedilo, l’allevatore passò la sua prigionia in condizioni atroci e disumane che misero a dura prova la sua salute: sepolto vivo nel fienile, in una stanzetta segreta, abitata da topi e parassiti, cui si accedeva da un buco alto un metro e sessanta e coperto da balle di fieno. «Contavo e pregavo, era il mio modo di scandire il tempo» – riferirà Titti in seguito.
All’epoca ci si chiese come mai nessuno si fosse accorto della presenza dell’ostaggio: la zona era frequentata da operai e fornitori dello stabilimento e, tra l’altro, era stata setacciata più volte. Qualche giorno in più e, forse, quel silenzio sarebbe durato per sempre.
La sera stessa furono arrestati Salvatore Atzas, che aveva in uso l’ovile-prigione, e Natalino Barranca, il servo pastore. Il primo è stato condannato, in via definitiva, a 30 anni di reclusione per aver organizzato il sequestro; il secondo – dapprima condannato a 17 anni di carcere, in quanto custode dell’ostaggio – è stato assolto nel 2015 dalla Corte di Cassazione per non aver commesso il fatto.
Dopo l’inchiesta bis della DDA di Cagliari, nel 2015 sono fioccate altre condanne. Quella di Francesca Sanna, la donna della banda, condannata con rito abbreviato a 11 anni di reclusione; quella di Giovanni Maria “Mimmiu” Manca, condannato a 28 anni di carcere per aver condotto il furgone con a bordo l’ostaggio nella seconda fase della fuga e, infine, quella di Antonio Faedda, il cui ruolo di apripista nella sera del rapimento gli ha negato la libertà per 25 anni. Attualmente per Faedda è in corso il processo d’appello, per Manca inizierà a luglio.
A Bonorva, la famiglia Pinna capitò più volte nel mirino dei ladri di uomini. Il 29 aprile del 1967 fu la volta di Giuseppe Pinna, rapito mentre rientrava in paese da un terreno di sua proprietà e liberato nelle campagne di Bono, dopo il pagamento dei 25 milioni di lire chiesti per il riscatto. Poi, nel settembre del 1977, Luigi e Giovanni Maria Pinna (rispettivamente il padre e lo zio di Titti) scamparono ad un tentativo di sequestro, proprio davanti all’azienda di “Monti Frusciu”. Infine, il 7 settembre 1980, i ladri di uomini si presero Giovanni Battista Pinna, zio omonimo di Titti, il quale, purtroppo, non fece più ritorno a casa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA