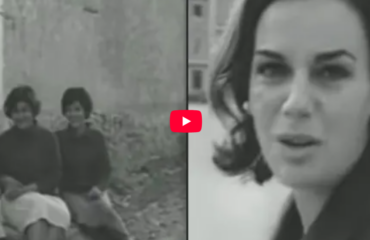La Necropoli Sas Concas, i villaggi Serra Orrios e Sa Sedda ‘e Sos Carros: un viaggio nell’Isola lontana

Il territorio del Nuorese è ricco di testimonianze di un passato remoto, affascinante e suggestivo. Oggi il viaggio comprende tre mete: la Necropoli prenuragica Sas Concas, il villaggio nuragico di Serra Orrios e Sa Sedda ‘e Sos Carros, suggestivo “paese” preistorico: un viaggio nella Sardegna che fu, tra tombe, villaggi e culti particolari.
canale WhatsApp
Il territorio del Nuorese è ricco di itinerari archeologici di notevole interesse.
Abbiamo nuraghi, pozzi sacri, domus de janas, menhir, templi, tombe dei giganti: qui fare un viaggio coinvolgente e suggestivo in quel che fu è ricco, variegato e affascinante.
Oggi il viaggio comprende, tra le tante del territorio, tre mete: la Necropoli prenuragica Sas Concas, il villaggio nuragico di Serra Orrios e Sa Sedda ‘e Sos Carros, suggestivo “paese” preistorico.
La Necropoli Sas Concas a Oniferi, viaggio tra venti tombe con particolari incisioni antropomorfe
È considerato il più esteso e antico complesso di domus de janas della Barbagia ma è anche importante per altri, particolari dettagli: la Necropoli Sas Concas si contraddistingue infatti anche per misteriosi elementi architettonici e simbolici.
Sì, perché in questo territorio le sepolture ipogeiche sono quasi sempre state ritrovate isolate o raggruppate in piccoli gruppi, mentre Sas Concas è composto da venti tombe tutte vicine. In più, sulle pareti di alcune tombe (dell’Emiciclo, della Tomba X e della Tomba Nuova Ovest) sono state ritrovate incisioni particolati. Ma andiamo nel dettaglio.
La necropoli, databile al 2700 a.C. circa, si trova in territorio di Oniferi, in un affioramento di tracheite: ricco di siti nuragici e prenuragici, il territorio del paese barbaricino offre un’ampia offerta di viaggi nel tempo, da necropoli a nuraghi, passando per menhir e domus de janas.
Ma, tornando a Sas Concas, partiamo con la tomba dell’Emiciclo, struttura complessa: un’anticella permette l’ingresso, attraverso un portello, in una grande stanza semicircolare, con tetto spiovente. Altre cinque celle secondarie si possono raggiungere da qui. Su tutte le pareti è presente una banda a rilievo, in un angolo è raffigurata una lesena mentre c’è, sul portello al centro della parete di fondo, un falso architrave a rilievo. A sinistra della parete di fondo, sono incisi undici petroglifi antropomorfi capovolti. Si ipotizza possano rappresentare i defunti. Senza un particolare e determinato schema, le incisioni continuano a sinistra, mentre sulla parete opposta è presente una sola figura umana, ovviamente stilizzata e capovolta.
Anche nella Tomba Nuova e nella Tomba X sono state documentate analoghe raffigurazioni. Per la precisione, la Tomba Nuova è caratterizzata da una planimetria particolare: un lungo corridoio introduce nell’anticella, con due nicchiette poste lateralmente. Un terzo ambiente, disposto sullo stesso asse dei precedenti, presenta ingressi ad altrettanti vani, con uno schema a T. In questo caso, i petroglifi sono sulla parete prospicente l’ingresso della camera.
Il Villaggio Nuragico di Serra Orrios, a Dorgali, che racconta la vita dei nuragici
Imperdibile per chiunque voglia farsi un’idea della vita dei nuragici è la visita al Villaggio Nuragico di Serra Orrios, a Dorgali: si tratta di un “sito urbano” articolato e ben conservato che, posto su un altopiano con vista sul mare e circondato da rilievi, ulivi millenari e macchia mediterranea, racconta la vita dei nuragici con precisione.
Si parla, in questo caso, dell’Età del Bronzo, quando la cultura nuragica prosperava, florida.
Il villaggio è composto da un centinaio di ambienti: 49 sono le capanne – con stanze e posti per gli animali –, due tempietti a megaron con recinto, due tombe megalitiche, una Tomba dei Giganti e una di tipologia incerta.
Le capanne – com’era in uso all’epoca – erano formate da una base circolare (con filari irregolari di pietra basaltica) e da un tetto coperto da tronchi e frasche.
Lastre di pietra formavano il pavimento e nei muri spesso c’erano delle nicchie dove i nuragici potevano porre i loro oggetti di vita quotidiana. Argilla e sughero rendevano la struttura impermeabile, mentre il focolare era sempre al centro delle capanne, vicino all’ingresso.
Sembra scontato, ma tutto era studiato nei minimi dettagli in modo che le esigenze degli uomini fossero garantite al meglio.
La maggior parte delle capanne formavano isolati con più vani, avevano un cortile e un pozzo in comune. La capanna 49 tuttavia è diversa: viene chiamata “capanna delle riunioni” proprio perché nella parete interna è presente un bancone-sedile. Probabilmente – anche per il fatto che un vestibolo formato da massi di dimensione più grande della normale preceda l’ingresso – veniva usata per scopi sacri, per riunioni della popolazione o per attività pubbliche.
I due tempietti a megaron contraddistinguono il villaggio per la loro tipologia architettonica, che indica una probabile ispirazione all’architettura micenea. Numerosi i reperti rinvenuti che danno, appunto, informazioni della vita del villaggio dall’epoca del Bronzo Medio a quella del Ferro, soprattutto per quanto riguarda agricoltura, artigianato, allevamento. Ricco il materiale ceramico rinvenuto: dalle brocche ai tegami decorati, dai vasetti a ziri che dovevano conservare derrate alimentari. Molti elementi attestano quanto fiorente fosse l’industria tessile.
Sa Sedda ‘e Sos Carros a Oliena, un tempo culla di civiltà preistorica
Sa Sedda ‘e Sos Carros (a Oliena), letteralmente “Punto di passaggio dei carri” – nome che risale alle attività di raccolta di carbone e legna del Diciannovesimo e Ventesimo secolo –, è un complesso nuragico composto da un esteso numero di capanne – a pianta circolare o ovale – che spicca per ingegneria e architettura.
È un villaggio simile a molti altri della Barbagia, si differenzia però dal fatto che si sviluppò senza un nuraghe di riferimento: risale a un periodo compreso tra Bronzo Recente e prima Età del Ferro ed è importante perché molte sono le attestazioni legate alla fusione dei metalli. Incastonato nella valle di Lanaittu, è un insieme di unità abitative legate al culto delle acque: i complessi interessati da questo culto in Sardegna sono contraddistinti da edifici che erano costruiti con l’intento di captare e canalizzare le acque.
Si parla di un tempo nel quale l’uomo imparava a estrarre e forgiare metalli – ovviamente si parla di bronzo e ferro – e questo è ben chiaro visti i numerosi ritrovamenti di oggetti fatti con questi metalli.
Nel complesso nuragico spicca un’unità: viene chiamata “la fonte” ed era legata a funzioni rituali. Si tratta di un ambiente circolare con pareti interne in blocchi bicolori (calcare bianco e basalto scuro) e pavimento lavorato con cura, partendo da un piano naturale in calcare. Sulle pareti, perfettamente scolpite, si trovano teste di muflone e/o ariete con un foro dal quale l’acqua zampillava nel bacile monolitico al centro del pavimento. Vicino a questa particolarissima capanna, c’è una grande struttura a gradoni: era presumibilmente qui che si svolgevano le abluzioni cerimoniali che prevedevano l’uso dell’acqua sacra.
Contenuto realizzato in collaborazione con la Regione Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio

© RIPRODUZIONE RISERVATA