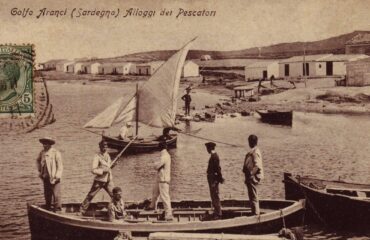Monumenti sardi: l’altare rupestre di Santo Stefano, uno dei luoghi più misteriosi e affascinanti dell’Isola

Nel territorio di Oschiri, in mezzo alla campagna, si trova un monumento tanto enigmatico quanto spettacolare e particolare. Stiamo parlando dell'altare rupestre di Santo Stefano. Andiamo alla scoperta di questo sito così misterioso che ancora scatena dibattiti tra studiosi e appassionati per la datazione e la funzione.
Monumenti sardi: l’altare rupestre di Santo Stefano, uno dei luoghi più misteriosi e affascinanti dell’Isola.
Nel territorio di Oschiri, in mezzo alla campagna, si trova un monumento tanto enigmatico quanto spettacolare e particolare. Stiamo parlando dell’altare rupestre di Santo Stefano. Andiamo alla scoperta di questo sito così misterioso che ancora scatena dibattiti tra studiosi e appassionati per la datazione e la funzione.
Già di per sé il luogo dice tantissimo: alle pendici del Limbara, al confine tra Logudoro e Gallura, nelle campagne di Oschiri, si trova un luogo incantato, che pare abitato da janas e folletti, tanto sono particolari e uniche le strutture scolpite letteralmente nella roccia.
In un un banco di granito lungo circa dieci metri sono state scolpite con precisa sequenza una serie di incisioni geometriche. Una ‘tavola’ di pietra è stata definita ‘altare rupestre’ perché si trova di fronte alla chiesa di Santo Stefano, che dà il nome al sito.
 Vicino, sparse in un boschetto di querce e macchia mediterranea, troviamo una necropoli con otto domus de janas, circondate da numerose rocce adattate a nicchie, alcune delle quali sono sicuramente state scavate dall’uomo, altre invece dal lento e incessante agire degli agenti atmosferici nel tempo.
Vicino, sparse in un boschetto di querce e macchia mediterranea, troviamo una necropoli con otto domus de janas, circondate da numerose rocce adattate a nicchie, alcune delle quali sono sicuramente state scavate dall’uomo, altre invece dal lento e incessante agire degli agenti atmosferici nel tempo.
Sull’ampia parete granitica dell’altare sono stati incisi motivi di varie forme, combinati tra di loro: incavi triangolari, quadrangolari e semicircolari, attorno decine di coppelle e croci.
Tra necropoli e altare sono individuabili altre quattro rocce istoriate, ricche di fascino quanto di sacralità: una con tre nicchie quadrangolari e coppelle sopra e sotto; un’altra con due incavi triangolari e un bancone, usato forse per offerte votive o rito dell’incubazione; una nicchia rettangolare, assimilabile a una tomba a tafone; infine una ‘meridiana’ costituita da un incavo circolare, sormontato da uno scalino e circondato da coppelle.
 Alcune incisioni sono state ‘cristianizzate’ con la croce, che serviva a cancellare la presenza di antichi riti pagani.
Alcune incisioni sono state ‘cristianizzate’ con la croce, che serviva a cancellare la presenza di antichi riti pagani.
La datazione è tuttora incerta: la necropoli ipogeica potrebbe appartenere ad un periodo che va dal Neolitico recente e l’età del Rame (IV-III millennio a.C.). Ma c’è anche chi la fa risalire a dopo l’avvento di Cristo o a età bizantina. Mentre l’assenza di un’indagine archeologica ha dato adito alle più disparate interpretazioni, i simboli nelle rocce, però, non trovano spiegazione. Sono ‘disegni’ privi di confronti, legati a sacrifici e riti e con valori sacri profondi, riconducibili a simboli divini o all’astronomia.
Santo Stefano è un’area dalla sacralità evidente e toccabile, a prescindere dal periodo a cui può essere ricollegato: si è anche supposto che vi partorissero le sciamane o si praticasse il rito della scarnificazione (prima di deporre il cadavere dentro le domus). La disposizione di figure geometriche e coppelle non è casuale: sembrano descrivere il passaggio dal mondo dei vivi a quello dei morti. I quadrati sarebbero le ‘false porte’, tipiche di domus e tombe di Giganti, punto di contatto tra terra e aldilà. I cerchi sono simbolo pagano di continuità, infinito, divinità solari, astri.
I triangoli sono identificabili con i luoghi della preghiera. Sempre qui è stato eretto a fine XV secolo – forse su un edificio bizantino – il santuario campestre per sostituire o assorbire i poteri sacri. Anch’esso pare custodire segreti: un piccolo betilo nuragico adattato ad acquasantiera e due volti stilizzati della dea fenicia Astarte inseriti in facciata.
Nell’ingresso meridionale, un architrave di trachite reca un’iscrizione bizantina (o in antico logudorese) con la data di edificazione: 1492. La pergamena scoperta durante il restauro riporta la consacrazione al 1504.

© RIPRODUZIONE RISERVATA