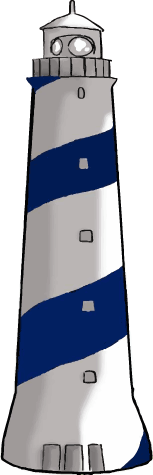Paolo Pillonca si è spento a Cagliari a causa di una malattia oggi, 26 maggio all’età di 76 anni. Fu scrittore, giornalista professionista e profondo conoscitore della cultura sarda di cui era grande cultore e promotore.
A Giacomo Mameli, giornalista e amico di Paolo Pillonca, abbiamo chiesto un suo ricordo personale. Eccolo.
«Un fratello, un amico, un compagno di lavoro.
Un fratello, prima di tutto. Perché la nostra comune casa di formazione è stato l’istituto salesiano, “il collegio” di Lanusei, in una scuola di eccellenza che oggi non c’è più ma che ha formato intere generazioni di professionisti, fra tutti Giovanni Lilliu, accademico dei Lincei, il sardus pater dell’archeologia. Stando insieme per anni si diventa fratelli. E con Paolo, che aveva un anno in meno di me (io ho superato i 77), ho passato tanti anni, a studiare perifrastiche e Tito Livio, a capire il valore sommo dell’amicizia, della lealtà, dell’impegno quotidiano fra libri di testo e campi di calcio. Con gli sms, con whatsApp, ci chiamavamo “fradi miu”, lo stesso era per le nostre famiglie, per i nostri figli, pranzi e cene, gite bucoliche fra ovili e vigne. E anche occasioni ufficiali, conferenze, convegni, incontri politici. Ma tutti scanditi dall’amicizia e dall’humanitas, il tratto impresso dalla scuola di don Bosco.
Un amico, poi. Condividendo passioni politiche e civili. Apprezzando entrambi la bellezza incomparabile delle campagne dell’Ogliastra, fra mare e montagne. Seui (dove domani pomeriggio verrà sepolto) era la sua Itaca come per me lo è Perdasdefogu che anche Paolo chiamava Foghesu. E dove tutti lo ricordano per le sue conferenze, era stato lui – con Enrica Delitala e Giampaolo Mele – a inaugurare la rassegna Foghesu canta Foghesu. Da noi parlava in foghesino puro, così come in Logudoro sfoggiava un logudorese di pregio, a Nuoro un barbaricino quasi ciceroniano, in Baronia la parlata cadenzata di Orosei e Siniscola.
Un compagno di lavoro. Come giornalista. Lui che ha sdoganato il sardo nei quotidiani isolani, prima a L’Unione Sarda con quel maestro di giornalismo che è stato Vittorino Fiori e poi a La Nuova Sardegna. E ai microfoni della Rai. E i suoi tanti libri, da “Chent’annos” a “Narat su diciu”. Ma soprattutto lo studio sistematico dei poeti dialettali, da Remundu Piras a Peppe Sotgiu, ai poeti di Silanus e della Baronia. Li ha conosciuti tutti, li ha studiati tutti, li ha registrati tutti, li ha portati tra le gente senza relegarli in una sterile accademia. Paolo è stato l’enciclopedia della poesia sarda.
Cronista di razza, attendo osservatore dei fondamentali del giornalismo, per dieci anni capocronista delle popolari pagine de L’Unione a di Nuoro dove vendeva migliaia di copie. Faceva il giornalista con lo scrupolo del professore di Lettere, dalle aule del liceo di Seui a quelle dell’università. Poeta anche lui, autore di testi per Piero Marras, attore per il cinema, intellettuale poliedrico e sobrio, ottimo parlatore in pubblico (“non si parla mai per più di quindici minuti, devi dire l’essenziale”). Scriveva l’essenziale anche quando si occupava di politica e di sequestri di persona, dei drammi di Orune e Orgosolo, col rispetto dovuto ai paesi del malessere come nessun altro giornalista ha saputo fare. Anche battendo sulla sua Olivetti e poi sui tasti del computer dettava legge morale la sua humanitas, quella appresa da bambino nel “collegio di don Bosco”. È rimasto un classico, un latinista e un grecista. Negli ultimi mesi di vita, con la moglie e i figli sempre vicini, il male lo ha fatto soffrire. Oggi Paolo citerebbe Quintiliano: “Mors malorum finis est”, la morte è la fine di tutti mali. Ma anche di tutti i miti. E tu, Paolo, un mito sei stato. In sa santa gloria».

© RIPRODUZIONE RISERVATA